Una polemica così aspra, così aperta e così prolungata in pieno fascismo non era cosa di tutti i giorni. Ma la diatriba sul ruolo della psicoanalisi che nel corso del 1932 contrappose i custodi dell’idealismo e i pochi seguaci italiani di Sigmund Freud avrebbe rivelato nei decenni successivi il suo carattere anticipatore: in Italia le scienze umane – la psicoanalisi e la sociologia in primis – hanno dovuto farsi largo sfidando poteri forti, ma forti davvero. Poteri politici, culturali, accademici. In quel 1932 Guido De Ruggiero, a nome dell’idealismo imperante, aveva provato a confutare sulla Critica i capisaldi della psicoanalisi arrivando a definirla «museo degli orrori». Sul Saggiatore gli aveva risposto in più occasioni Nicola Perrotti, uno dei pochissimi psicoanalisti dell’epoca: e lo aveva fatto con una verve insolita per quegli anni. «De Ruggiero si fabbrica una dottrina psicoanalitica a modo suo e poi si affanna a combattere questo suo fantasma […] La sua non è una critica, è uno sfogo pre-critico, una bizza al di là di ogni valutazione». Una risposta circostanziata punto per punto e non ideologica, concentrata a smontare i pregiudizi e riassunta in una sintesi: quello di De Ruggiero era «un museo degli errori».
Gli «orrori» di De Ruggiero e gli «errori» di Perrotti: in quel gioco di parole c’erano due diversi approcci, uno altezzoso e l’altro empirico. Ma in quella polemica c’era soprattutto il preannuncio dell’ostilità di poteri che si manifestarono negli anni Trenta (fascismo, idealismo, Chiesa) e poi si moltiplicarono nel dopoguerra: la cultura accademica, il potere politico, mai così sessuofobico come ai tempi della Dc. E aspra fu l’ostilità della cultura comunista: che, proprio come gli altri approcci “totalizzanti”, diffidava del carattere liberatorio di discipline che studiavano i percorsi interiori e sociali dell’uomo. Scienze del libero arbitrio e della ricerca empirica che allora come oggi – e in questo c’è un’ evidente attualità – continuano a far valere lo spirito critico rispetto al pregiudizio.
Decisivi allora per rompere l’isolamento si rivelarono alcuni pionieri, quasi tutti accomunati dalla stessa cultura socialista e laica in senso lato: anche se non mancò il contributo di diversi studiosi cattolici. Personaggio centrale della polemica del 1932 – ma poi in tante successive battaglie di “liberazione” dai pregiudizi verso le scienze umane – era stato il trentenne Nicola Perrotti, che negli anni successivi si sarebbe rivelato un intellettuale tra i più originali del dopoguerra per la sua doppia vocazione: la fede socialista e quella per la psicoanalisi, disciplina che difese quando era eresia e poi contribuì a diffondere dal 1945 in poi, battendosi per applicazioni sociali mai sperimentate prima.
Abruzzese di Penne, nel 1921, all’età di 23 anni, Perrotti era stato eletto sindaco del suo paese, ma aveva presto pagato per il suo antifascismo. Aggredito, inserito nell’elenco dei sovversivi, sorvegliato speciale, i circostanziati rapporti redatti dalla polizia fascista raccontano la sua personalità in modo persino più eloquente di quanto non abbiano potuto fare nei decenni successivi amici e allievi. Gli estensori dovettero rilevare che Perrotti – pur continuando a coltivare con «fervore» le sue teorie socialiste – «nella professione è bene accreditato perché ritenuto studioso equo nei compensi che richiede», «di buona moralità, generoso con le classi umili e con i poveri, cui presta gratuitamente la sua opera professionale».
Nel contesto così soffocante della sua Penne, paese alle falde del Gran Sasso, fisicamente (e non solo) lontano dalle correnti più avanzate del pensiero europeo, in un’epoca nella quale i testi eretici non erano facilmente accessibili, questo medico socialista si appassionò alla psicoanalisi scrivendo saggi che subito attirarono l’attenzione di Sigmund Freud, che dopo averne letto uno sulla suggestione scrisse a Edoardo Weiss: «Il Suo collaboratore Perrotti promette di diventare un elemento di sicuro valore», Nel 1932 la Spi (Società psicoanalitica italiana) venne rifondata a Roma, oltreché da Edoardo Weiss, da Emilio Servadio, Cesare Musatti e Nicola Perrotti: i primi tre di origine ebraica, gli ultimi due di fede socialista. Un doppio dna eloquente. E infatti durò poco: la Rivista italiana di psicoanalisi e la Spi furono sciolte dal regime fascista su richiesta della gerarchia cattolica.
Ma nel 1942, quando i destini della guerra erano ancora incerti, Perrotti è tra i promotori delle prime riunioni clandestine per la ricostituzione del Partito socialista: e poi, tra l’estate del 1943 e il 4 giugno 1944, la sua casa romana diventa uno dei luoghi di incontro, perché, come racconterà Giuliano Vassalli, «la sua funzione di medico» consentiva di camuffarli come visite. In effetti riunioni pericolose: al termine di uno di quegli incontri furono arrestati Saragat e Pertini e ovviamente in quei giorni nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbero diventati entrambi Presidenti della Repubblica.
Dal 1944 nella Direzione del Psiup, Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità pubblica nell’ultimo governo tripartito guidato da De Gasperi, Perrotti è tra i pochi socialisti che nel 1948 riescono ad essere eletti, con le preferenze, nelle liste del Fronte popolare. Di tutta questa stagione vissuta nella prima linea politica finirà per avere un valore profetico l’essenza del discorso al congresso del Psiup di Firenze del 1946: intervenendo contro l’ipotesi di partito unico della sinistra, Perrotti usa argomentazioni che diventeranno moneta corrente ma soltanto qualche decennio più tardi: «Io sono convinto che questa idea fissa dei nostri rapporti col partito comunista sia diventata una idea ossessiva […] che paralizza la nostra azione», anche perché «la sfiducia iniziale del nostro partito si è tradotta in un vero e proprio complesso di inferiorità nei confronti del Pci». Una lettura che senza pedanterie psicologistiche, coglie un punto delicato: quel complesso nei confronti dei comunisti dal quale i socialisti italiani proveranno a liberarsi soltanto 30 anni dopo. La stessa sottigliezza anticipatrice in un intervento alla Camera sulla legge-truffa, nel quale si rivolge a De Gasperi, che aveva chiesto il voto di fiducia: «Ci ha detto che dobbiamo aver fiducia in lui», ma lo ha fatto «senza riflettere che gli uomini politici sono sempre prigionieri delle situazioni in cui si vanno a cacciare e che sono queste situazioni, e non le loro intenzioni, a determinare la loro condotta».
Ma nei primi anni del dopoguerra le due vocazioni di Perrotti – quella politica e quella psicoanalitica – si intrecciano con riverberi concreti nella vita pubblica. Per lui – come dimostrerà nella terapia, nei seminari, nelle conferenze – la psicoanalisi era un mezzo per alleviare le sofferenze personali e allo stesso tempo un’arma per combattere i conformismi e le repressioni della società.. E infatti portano la sua impronta novità destinate a cambiare la vita di tante persone deboli, afflitte da debolezze psicologiche e sociali.
Alla fine del 1946 partecipò a Tramezzo, sul lago di Como, ad un convegno che secondo un protagonista come il giovane Adriano Ossicini cambiò «il ruolo della psicologia» sociale in Italia. Proprio da Perrotti parte l’impulso determinante per l’ approvazione di una legge che istituisce la Scuola nazionale per dirigenti del lavoro sociale: la prima di queste in ambito universitario, con la sua supervisione, è affidata a Guido Calogero. E sempre alla fine del 1946 Perrotti e Ossicini scrivono un progetto di riforma degli ospedali psichiatrici, ipotizzandone una progressiva trasformazione che porti ad una loro chiusura. Siamo nel 1946: in quel momento nessuno immaginava una misura così drastica, ma quel documento fu una pietra miliare sulla strada che 32 anni dopo avrebbe portato alla chiusura dei manicomi.
Col ritorno della democrazia i pochi psicoanalisti italiani erano potuti tornare a lavorare alla luce del sole e venne ricostituita la Spi, della quale nel 1947 Perrotti diventa presidente. Il suo spirito anticonformista lo porta, nel 1948, a fondare Psiche, una rivista che oltre a sprovincializzare l’ambiente freudiano italiano di nuovo anticiperà i tempi col suo interesse per la psicopatologia quotidiana. E quindi con una lettura psicologica della politica, dell’arte, della letteratura, della morale e di fenomeni psico-sociali come il matrimonio, lo sport e la moda. E proprio le reazioni alla novità di Psiche segnalano una differenza tra mondo cattolico e mondo comunista.
Perrotti aveva chiesto per iscritto a padre Agostino Gemelli, il personaggio più aperto nella gerarchia cattolica verso le discipline psicologiche, se volesse far parte del Comitato d’onore della rivista: e nella risposta («ben volentieri accetterei, ma obbligherebbe me a chiedere il consenso dei miei superiori»), c’è anche la richiesta se in futuro sarebbe stato «possibile scrivere un articolo». Interessamento significativo quello di Gemelli anche se non rispecchia l’orientamento della Chiesa, che invece era diffidentissima, avendo intuito nella psicoanalisi una pericolosa concorrente. Denunciando il «pansessualismo» e il «materialismo», le gerarchie dissimulavano la vera ragione della loro ostilità: la cifra ideologica e l’ambizione “totalitaria” delle teorie freudiane, attitudini che rischiavano di rubare alla Chiesa il monopolio dell’anima ma anche quel rosario di segreti personali fino ad allora custoditi in confessionale.
Allora anche il Pci, a suo modo, era una chiesa: e infatti prese di mira Psiche, nonostante fosse diretta da un deputato del Fronte popolare. In un articolo pubblicato il 3 agosto 1950 sull’Unità e in successive messe a punto un ex partigiano come il filosofo Antonio Banfi contestò le incursioni in campo sociale e politico della rivista, rivendicando il monopolio di una lettura marxista. In questo Banfi era in linea con Togliatti, che due mesi prima aveva espresso un giudizio lapidario sulla psicoanalisi: «Purtroppo quando si parte da Freud si può andare a finire molto lontano, in una casa Merlin o in un manicomio». Un approccio reazionario che mal si conciliava con quanto Antonio Gramsci aveva annotato in carcere nei suoi Quaderni proprio a proposito dalla polemica tra La Critica e Perrotti: «Il De Ruggiero ha scritto una stroncatura un po’ affrettata e superficiale di Freud e della psicoanalisi». Senza preoccuparsi di approfondire Gramsci, il Pci si richiuse nella piccola fortezza del pavlovismo, tanto è vero che ancora nel 1960 Pier Paolo Pasolini scriveva: «Il marxismo non ha mai affrontato in modo soddisfacente il problema dell’irrazionalità», e «rinunciando all’introspezione, il critico marxista militante spesse volte è vittima del suo inconscio».
La stessa diffusa ostilità inseguì nel dopoguerra altre scienze umane, a cominciare dalla sociologia: che dopo aver vissuto una stagione d’oro nell’Italia umbertina aveva subito l’ostracismo di Benedetto Croce («l’inferma scienza»), e conobbe poi un faticoso recupero. Oltre alla rivolta degli anti-crociani contro «la dittatura dell’idealismo», come la definì nel 1947 Remo Cantoni sul Politecnico, molto si deve alla ricerca sul campo di spiriti liberi come Adriano Olivetti, Vittorio Foa, Ezio Vigorelli, Roberto Tremelloni, Luciano Cavalli, Alessandro Pizzorno, Achille Ardigò, Franco Ferrarotti.
La psicoanalisi restò a lungo una grande incompresa. Negli anni Cinquanta Perrotti – assieme a Musatti e Servadio – contribuì a rompere l’assedio del provincialismo italiano: nel suo Istituto di Psicoanalisi di Roma promosse scambi con le principali personalità del movimento freudiano internazionale, da Winnicot a Lacan, da Bouvet a Spitz, da Balint a Nacht. E l’isolamento via via si allentò. Attorno alla psicoanalisi si accese l’interesse di editori come Astrolabio, Einaudi e Boringhieri, e finalmente negli anni Sessanta si ruppero gli argini. Nel 1964 Il male oscuro di Giuseppe Berto (del quale il Perrotti analista era stato “ispiratore” e stimolo) divenne un significativo caso letterario, vincendo nella stessa settimana il Premio Campiello e il Premio Viareggio. Erano trascorsi più di trenta anni dalla polemica tra Il Saggiatore e La Critica crociana e la psicoanalisi non soltanto era entrata nella cultura “alta”, ma le categorie freudiane erano oramai recepite nell’interpretazione di diversi fenomeni sociali.
Nicola Perrotti aveva continuato la sua attività di analista: allievi e pazienti ne ricordarono sempre l’intelligenza “antropica”, la capacità di penetrare l’animo umano. E la disponibilità a lasciarsene penetrare, come suggeriva lui stesso, definendo «l’’angoscia dello psicoanalista», cioè quello «speciale bisogno di certezza e di dubbio metodico che è inerente alla professione». Coltivando una concezione dell’analisi individuale, per cui il traguardo è non tanto la fuggevole “normalità” psichica, quanto la pienezza di funzioni: che si può raggiungere attraverso l’esperienza vissuta dei conflitti, e una coscienza che è sinonimo di libertà. Una concezione dell’individuo e della psicoanalisi rispecchiata in una sua frase riferita da un allievo, lo psicoanalista Giancarlo Petacchi: «Non importa quanta luce si emette, l’importante è brillare di luce propria, non di luce riflessa». E dopo essere stato appassionato difensore della psicoanalisi in anni nei quali tutto questo precludeva carriere e titoli accademici, quando le ostilità si dissiparono gli capitò di rimproverare agli articoli della ufficiale Rivista di Psicoanalisi toni troppo dotti e difficilmente accessibili anche ad un pubblico colto.
Aveva lasciato il Parlamento nel 1953, e pur restando amico e medico di Pietro Nenni non faceva più vita di partito. Eppure nel 1970 – nonostante fosse reduce da due infarti – accettò la richiesta del suo vecchio partito di dare una mano, tornando in azione in occasione delle prime elezioni Regionali in Abruzzo. Pochi mesi più tardi, il 7 settembre 1970, cinquanta anni fa, il terzo infarto gli fu fatale. Giuliano Vassalli, nella commemorazione alla Sapienza, ricordò il suo ultimo ritorno a Penne: dove «la sua figura era diventata quasi leggendaria» per la «generosità» e «per il modo in cui elargiva consigli» e «medicinali in suo possesso» ai più bisognosi, in un’epoca nella quale non esisteva il servizio sanitario nazionale; e per come «si prodigava nel recarsi nei luoghi più lontani […] tanto che qualche contadino era giunto a chiamarlo “San Nicola”». Durante il ventennio fascista Nicola Perrotti aveva sperimentato a proprie spese l’attualità permanente di quanto scritto nel Settecento da Samuel Johnson («non essere di nessuna chiesa è pericoloso»), ma nel dopoguerra contribuì a rompere il monopolio di tanti custodi della sapienza: quelli convinti che la libertà sia un pericolo e non la premessa di ogni progresso.


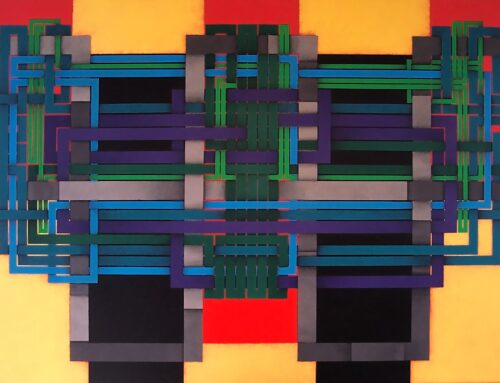



Scrivi un commento