La Costituzione italiana inanella una serie di tutele sul lavoro e a vantaggio del lavoratore che pervadono l’ordinamento a partire dall’articolo 1: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Fondamento e tutele che, in realtà, oggi più di ieri e domani più di oggi, rimangono lettera morta: una meravigliosa poesia che legislatore, datori di lavoro, sindacati, ispettorati del lavoro, lavoratori stessi leggono come fosse un’opera d’ingegno artistico senza darvi pieno seguito. Così come la funzione sociale della proprietà e dell’iniziativa economica, anche la funzione sociale del lavoro, la parità contrattuale tra uomo e donna, le garanzie salariali, le garanzie di solidarietà sociale e quant’altro rimangono lettera morta rievocata solo a seconda della convenienza politico-massmediatica del momento e poi riposta nel cassetto della memoria per l’utilizzo nel futuro comizio.
La situazione del lavoro in Italia è drammatica: sia nel gruppo delle grandi nazioni comunitarie sia in quello del G7, l’Italia è quella che presenta dati pessimi sull’occupazione – sia per quanto riguarda il dato assoluto sia per quanto riguarda il dato giovanile-, sulle garanzie reddituali, sull’inquadramento contrattuale, sul controllo e sul costo del lavoro. Se infatti è vero e sacrosanto che i lavoratori sono quelli più svantaggiati sul piano economico-sociale, altrettanto può dirsi dei datori di lavoro, per lo più piccoli e medi, che si trovano troppo spesso a dover fare i conti con un cuneo fiscale elevatissimo. Ma prima di analizzare questi due aspetti, è necessario che la nostra indagine vada a monte, valutando opportunamente mercato del lavoro e ragioni di una disoccupazione così elevata.
Da diversi anni, ormai, si è lasciato intendere che il lavoro deve essere un mercato, e tutti gli interventi dal 2000 in poi sono stati volti a rendere il lavoro sempre più soggetto alle regole di mercato. Questo ha portato a cedere, anche violentemente, sull’abbattimento delle garanzie reddituali ed occupazionali: se da un lato, paradossalmente, l’intervento del governo Monti venne additato, la riforma Fornero sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori garantiva ancora delle tutele che sono state annichilite dai governi successivi. Quelle tutele, a garanzia di tutti i lavoratori, sono state progressivamente elise e annullate.
Oltre a ciò, sembra essersi istituzionalizzata la possibilità di derogare ai contratti collettivi nazionali del lavoro da parte del privato. Sempre più spesso, infatti, assistiamo a situazioni limite, con lavoratori assunti con contratti pericolosamente arbitrari. Contratti formalmente tempo parziale e indeterminato che si trasformano in termini sostanziali in contratti a tempo pieno, contratti a tempo pieno e determinato con retribuzioni pericolosamente basse, contratti di stage retribuiti miserevolmente, contratti a tempo parziale e indeterminato in cui il lavoratore è costretto ad aprire una partita Iva per pagare autonomamente, in luogo del sostituto d’imposta, i tributi dal minimo contrattuale percepito.
Un contratto di lavoro su tre in tutta Italia, a voler essere ottimisti, non rispetta i contratti collettivi e non rispetta le garanzie reddituali e occupazionali. Ciò anche con il silenzio degli ispettorati del lavoro, che non effettuano i dovuti controlli se non saltuariamente e a campione. I controlli a campione effettuati nell’anno corrente forniscono, tramite il monitoraggio INL, dati allarmanti: tra gennaio e marzo 2021 sono state rilevate oltre quarantamila violazioni su quindicimila lavoratori (dato con una enorme crescita rispetto ai precedenti); un lavoratore su cinque è in nero (miglioramento rispetto al 2020 e al 2019 quando il dato era uno su quattro) ivi compreso il terziario (in cui dato è invece raddoppiato rispetto al 2020, triplicato rispetto al 2019 e quadruplicato rispetto al 2018). Non va meglio se aggiungiamo i dati pubblicati dalla stampa tra giugno e agosto: quattro aziende private su cinque ledono i diritti dei lavoratori, con violazioni sanitarie, civili, amministrative o penali; solo tra Prato e Pistoia, 64 imprese manifatturiere sono risultate irregolari con 250 posizioni illecite su 570 dipendenti.
I dati, già pochi e comunque figli di controlli a campione, forniscono senza dubbio un panorama desolante considerando che quanto emerge è solo la punta di un iceberg gigantesco. A ciò dobbiamo aggiungere le evidenze che nell’ultimo anno sono state sempre più spesso portate alla luce. Fin troppe sono offerte di lavoro con retribuzioni miserevoli reperibili online, tra le duecento e le quattrocento euro mensili per contratti part time e tra le trecento e le seicento per contratti a tempo pieno. Spesso, addirittura, le retribuzioni proposte sopra le quattrocento euro mensili sono soggette all’obbligo di apertura di partita Iva, come si è detto pocanzi, con le imprese datrici di lavoro che scaricano tutti gli oneri fiscali cui sono tenuti sul lavoratore.
La nota drammatica è data dal fatto che questo fenomeno è pericolosamente in crescita: diminuiscono infatti le offerte di lavoro tramite le agenzie interinali crescendo quelle online. Ciò è dovuto al fatto che spesso le agenzie interinali respingono, giustamente, offerte di lavoro simili, soprattutto per i percettori del cosiddetto reddito di cittadinanza. Ed è proprio la presenza del reddito di cittadinanza che ha permesso di rendere sempre più evidente questo abbattimento delle garanzie retributive nel lavoro: il reddito di cittadinanza non è la causa della mancanza di accettazione di lavoro; al contrario, il reddito di cittadinanza ha permesso di comprendere la gravità di offerte lavorative con retribuzioni basse. Questa misura, infatti, pone un limite sociale al mercato del lavoro, portando molti imprenditori a innalzare l’offerta di retribuzione e molti altri a lamentarsi della mancanza di volontà di lavorare. Certamente, quando l’offerta di lavoro è un contratto a tempo pieno e determinato senza giorno di riposo, senza straordinari retribuiti, con un mese di prova senza retribuzione, con una proposta di stipendio di 370 euro al mese appare chiaro che il mercato del lavoro non si autoregolamenta e che, anzi, c’è chi scambia il “mercato del lavoro” per la tratta degli schiavi.
Può quindi farsi una colpa ai giovani se preferiscono preservare la propria dignità lavorativa non svendendosi al primo posto di lavoro? Sin dagli inizi del 2000 i giovani hanno subito epiteti, insulti e spiegazioni, da “destra” a “sinistra”, fino alle spiegazioni del segretario PD Letta sul perché i giovani devono abituarsi a non avere prospettive lavorative stabili. Il problema sta nell’impossibilità di prospettive di vita in assenza di certezze lavorative: nessuno può addossarsi un mutuo per acquistare casa senza un lavoro stabile; nessuno programma un matrimonio e una vita familiare senza possibilità di prospettiva o certezza professionale. Il lavoro, e la sua stabilità, svolge una funzione sociale non indifferente che non può e non deve essere negata al variare del convincimento economico in una contingenza congiunturale.
I giovani, peraltro, hanno una scarsissima possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, se non in proprio per chi ne ha la possibilità, prima dei trent’anni: in Italia abbiamo il dato peggiore di NEET (disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 35 anni) nel G7 e nel gruppo di testa UE, con il mezzogiorno d’Italia che si attesta, quanto a possibilità lavorative per quella fascia d’età, tra le peggiori regioni in assoluto dell’UE e dell’intero continente europeo. Ciò è dovuto alla difficoltà di ricambio generazionale nelle imprese come anche nei segmenti pubblici.
Se da un lato i lavoratori piangono, molti imprenditori di certo non ridono. C’è anche questo dato da acclarare: il tessuto produttivo italiano è costituito largamente da imprese artigiane, micro imprese e piccole imprese, che rispetto alle medio-grandi imprese e ai gruppi industriali soffrono maggiormente il peso del cuneo fiscale. In Italia, non è un caso, il cuneo fiscale rappresenta quasi la metà della spesa su un dipendente per un’impresa. Appare subito chiaro, quindi, che una microimpresa non possa riuscire a mantenere un lavoratore con livelli salariali accettabili e sufficienti se deve poi dare quasi l’equivalente allo stato in gabelle varie. Diverso è il discorso per i grandi gruppi imprenditoriali e industriali, che cercano di limitare la spesa lavorativa non perché non possano sopportarne i gravami ma perché vogliono massimizzare i profitti anche a discapito dei lavoratori.
Un dato ulteriore da analizzare è anche l’anacronismo dei contratti collettivi nazionali del lavoro. Ad oggi i CCNL risultano essere troppi, talvolta poco chiare le differenze, talvolta inapplicabili. In aggiunta a ciò, troppo spesso ormai non inquadrano sufficientemente i le nuove professionalità, da quelle dei dipendenti del web a quelle più pratiche ricondotte analogicamente ad altre categorie facendo apparire o le nuove ultra-tutelate o le originarie scarsamente tutelate.
In definitiva, occorre complessivamente una revisione, in ottica sociale e sostenibile, del mercato del lavoro, che parta dalla limitazione di ribasso sulle retribuzioni, che abolisca o quantomeno limiti fortemente il ricorso alla partita Iva per i dipendenti, meccanismo usato per scaricare il cuneo fiscale direttamente sul dipendente, e che, al contempo, tenga conto delle difficoltà delle imprese artigiane, delle micro imprese e delle piccole imprese, tagliando severamente il cuneo che le appesantisce, e favorendo soprattutto la cooperazione tra queste.

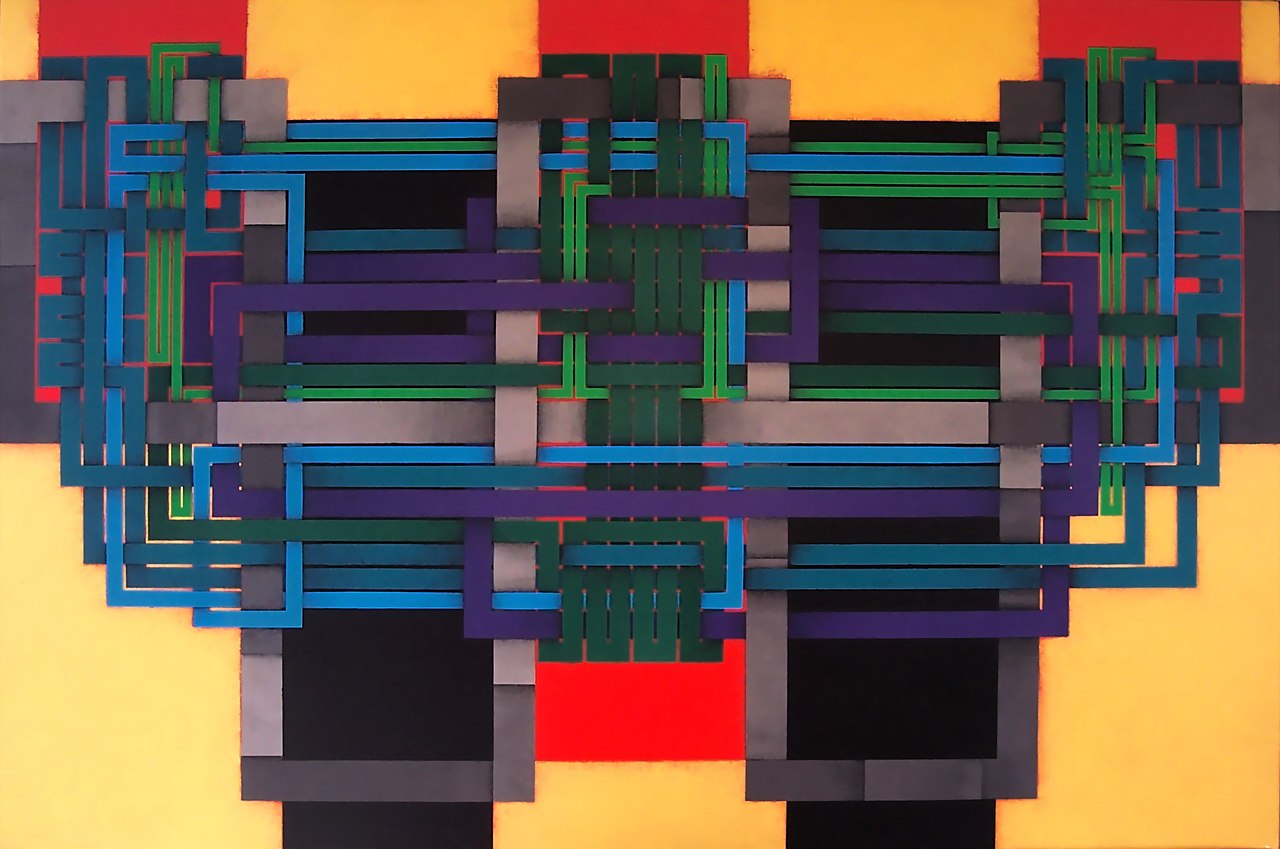




Scrivi un commento