Che dire della manifestazione di sabato a Roma? Che è stata poderosa? La Fiom un tempo sapeva far di meglio. Che è stata ordinata? Ci mancherebbe altro, con Di Pietro e Ingroia a dirigere il traffico. Che non c’erano i grillini? Anche per loro un pifferaio magico basta e avanza. Che è stata chiara negli obiettivi? Questo proprio non si può dire. In particolare non si è capito quale sia “la via maestra”. E’ l’articolo 138, “via maestra” per emendare la Carta? Ma negli argomenti degli organizzatori e negli umori della piazza l’articolo 138 si è ridotto a un comma 22: “Il Parlamento dei nominati vuole modificare la Costituzione aggirando l’articolo 138; l’articolo 138 riserva esclusivamente al Parlamento dei nominati il diritto di modificare la Costituzione”.
Non se ne esce. Così come i 5 stelle, che hanno “occupato” la terrazza di palazzo Montecitorio per difendere l’intangibilità del 138, non escono dalla contraddizione in cui proprio sulla nostra rivista (potete leggerlo qui accanto) è caduto Paolo Becchi, la cui autorevolezza in seno al M5S ormai è certificata, dopo che la sua proposta di impeachment per Napolitano ha avuto l’onore della prima pagina sul blog di Grillo. Per Becchi, infatti, “l’art. 138 presupponeva l’esistenza di un sistema elettorale a scrutinio proporzionale di lista, non truccato come quello attuale da un premio di maggioranza”: perchè ”con il sistema elettorale vigente all’epoca dell’introduzione della Costituzione non era semplice mutare la Costituzione sulla base dell’art. 138, dal momento che conseguire la maggioranza assoluta (e tanto più quella dei due terzi) senza il concorso della minoranza era piuttosto difficile”, mentre ora “si può dire che la Costituzione è nelle mani della maggioranza di governo”.
Bisogna ammettere che l’argomento è buono, ed avrebbe tranquillamente potuto essere fatto proprio dal governo per motivare la deroga una tantum al 138 prevista nel disegno di legge costituzionale ora oggetto del contendere. Così come bisogna convenire che un approccio più inclusivo alla scelta dei “saggi” incaricati di spiegare al Parlamento che la forma di governo può essere presidenziale o parlamentare ci avrebbe risparmiato un sacco di chiacchiere inutili (nonché qualche velina diramata dalla Procura di Bari).
Se non è il 138, comunque, “la via maestra” è la Costituzione così com’è: col bicameralismo paritario, i mille parlamentari, i quattro livelli di governo territoriale, ed anche (spiace per Grillo) l’articolo 67. E non perché Gustavo Zagrebelsky ha teorizzato di recente che la prima e la seconda parte della Carta sono intimamente legate, come Cristo con la Chiesa secondo la dottrina del Corpo mistico. Più semplicemente perché la sua intangibilità è protetta dal comma 22.
Si dirà (lo notava qualche giorno fa sul Corriere Angelo Panebianco) che è curioso che chi ha in così gran dispitto l’attuale sistema politico sia poi pronto a procombere per la difesa dello status quo costituzionale. Ma per quanti sono pronti a brandire l’armi contro i trentacinque saggi di ieri e i quaranta costituenti di domani la Costituzione del ’48 non è una procedura, è un programma politico. E’ il programma di quella “rivoluzione promessa” che secondo Piero Calamandrei le sinistre ottennero in cambio della “rivoluzione mancata”. Una promessa che finora non è stata onorata a causa della scarsa virtù dei politici, ma che ora può essere messa all’incasso a prescindere dalla politica, se non contro di essa. E pazienza se Calamandrei era fra i pochi che alla Costituente preferivano il presidenzialismo al parlamentarismo: per i falsari acculturati che transitano dalle cattedre ai palchi è comunque un precursore; e per chi acculturato non è, come Travaglio, alla fine è soltanto un piduista ante litteram.


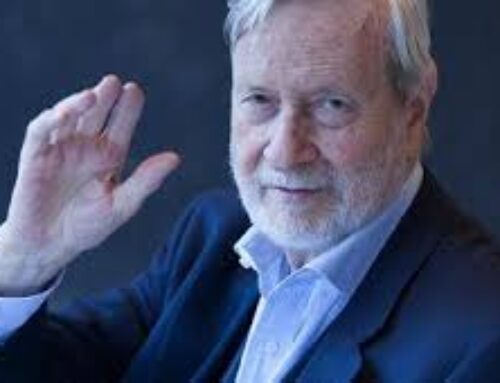



Diciamoci la verità: la deroga al 138 non c’entra nulla con la manifestazione di sabato.
Forse di quella deroga si poteva anche fare a meno perchè, alla fine, è più il tempo che si perde per farla entrare in vigore di quello che si guadagna. Ed anche il pregio maggiore, che irrigidisce il 138, quello di consentire di chiedere il referendum comunque, per le ragioni indicate da Covatta, deflazionando così la maggioranza dei due terzi dal premio di maggioranza, si sarebbe potuto conseguire facendo mancare apposta i due terzi.
Il punto è squisitamente politico: non ci si fida della maggioranza di larghe intese perchè si sa da dove inizia, ma non si sa cosa finirebbe per fare, secondo il classico argomento, quello del pendio scivoloso, di ogni conservatore che si senta minoritario. Argomento che in questi anni è stato usato soprattutto, in Italia, in occasione del family day contro il riconoscimento di diritti alle coppie di persone omosessuali.
Il problema è che non volendo cambiare le regole i manifestanti, se avessero successo nel mantenere lo status quo istituzionale, realizzerebbero una probabilissima eterogenesi dei fini: riuscirebbero a rendere quasi certe le larghe intese anche nella prossima legislatura.
Ognuno per me è libero di scrivere quello che vuole, salvo poi assumersene la responsabilità. Lei però mi ha frainteso. Il senso del mio discorso è chiaro : l’art. 138, considerata l ‘attuale situazione, andava semmai rafforzato, ovviamente seguendo la procedura prevista e non indebolito, seguendo una procedura alternativa. Il “rafforzamento” del resto, a suo tempo, era stato sostenuto dal fior fiore dei costituzionalisti italiani e, se non ricordo male, anche da quel geniale allievo di Giovanni Tarello che si chiama Riccardo Guastini. Insomma Lei ha preso, come si usa dire, un granchio.
Non capisco bene se l’apprezzamento per quanto dice Becchi è autentico o no, comunque, sono del tutto d’accordo. La nostra costituzione è da rivedere da cima a fondo: e ai suoi difensori odierni si potrebbe chiedere dov’erano quando negli anni scorsi essa ha subito oltre un centinaio di modifiche tra le quali quella, invero non piccola, dell’abolizione dell’immunità parlamentare.
Due cose: a Becchi avrei potuto replicare che la legge costituzionale prevede che la commissione dei quaranta sia formata con criterio proporzionale “depurando” la maggioranza dal premio (oltre al referendum, possibile anche in caso di maggioranza con i 2/3); quanto a Calamandrei potevi aggiungere non solo che si era pronunciato per il presidenzialismo ma che addirittura aveva previsto il controllo centralizzato dei pubblici ministeri attraverso un Commissario parlamentare che avrebbe fatto parte del Consiglio dei Ministri (ne parlo in un mio saggio su Quaderni costituzionali riprodotto in http://www.forumcostituzionale.it).
La carica autunnale dei centotrentottini lascerà il tempo che ha trovato. Brutto. La storia “costituzionale” di quei difensori della Costituzione è lunga e si identifica non con la “nobile” conservazione, ma con l’imbalsamazione della Carta. Contro, quindi, l’idea degli stessi Costituenti che la Costituzione italiana potesse e dovesse essere aggiornata. I grandi slanci riformatori dei centotrentottini giungono fino a sostenere che sì, la seconda parte della Costituzione (per intenderci L’ordinamento dello Stato) potrebbe anche essere “rivisitato”. Poi, però, per carità, non si tocchino i poteri del governo, non si elimini il Senato, non si elegga direttamente il Presidente della Repubblica. Nada de nada, altrimenti, nelle memorabili parole dello Zagrebelsky Gustavo, arriveranno uno o più generali al Quirinale.
Prima di discutere con costoro bisognerebbe invitarli a leggere qualche buon libro in materia di presidenzialismi e di semipresidenzialismi. E poi non sarebbero i Rodotà, gli Zagrebelsky, le Bonsanti, i Giulietti quelli che, sicuramente a loro insaputa, hanno già da tempo iniziato a smantellare la prima parte della Costituzione? Che non sia il caso di rivedere e forse di cassare l’art. 7? E non ci hanno martellato sulla necessità e l’urgenza di occuparci dell’imparzialità e del pluralismo dell’informazione (art. 21)? E qualcosina sul conflitto d’interessi, della cui carenza legislativa tutti loro in coro accusano la sinistra, non dovrà fare la sua comparsa nella parte prima? Per fortuna a dare man forte sono arrivati anche i Landini, che esigono precisazioni costituzionali sulla rappresentanza dei sindacati, o forse no. L’ultraottuagenario candidato dei grillini alla Presidenza della Repubblica vuole, infine, decisamente, anche la regolamentazione della vita interna e della democrazia dei partiti. O forse no.
Confondendo allegramente i diritti con le rivendicazioni, non parlando mai dei doveri, aggredendo il punto di equilibrio costituzionale – che oggi più di ieri si chiama Quirinale – i centotrentottini marciano a ranghi serratissimi sulla Via Maestra che conduce ad un bel niente. Sono i cattivi maestri di una larga fetta dell’opinione pubblica che si compiace di difendere una Costituzione che non conosce, non studia, non ha mai letto. Hanno anche insegnato male a non pochi degli esperti della Commissione i cui non esiti dovrebbero, invece, rallegrarli.
Non sono un costituzionalista o un competente studioso di temi istituzionali, ma mi sono fatto anche io le mie idee sulla Riforma della Costituzione. Indipendentemente, direi, da ogni elemento passionale: mettendo da parte, voglio dire, la mia scarsa sopportazione, ovvero l’antipatia, che nutro per molti degli organizzatori della manifestazione di sabato. A tal proposito, voglio qui dire che, pur leggendo quasi sempre con condivisione gli articoli di Panebianco, e pur essendo molto critico anche io come lui delle posizioni che tendono a fare della Costituzione un feticcio, l’articolo di sabato non mi ha convinto affatto. L’ho trovato debole nella critica e sbagliato nel ragionamento. Dal primo punto di vista, pecca troppo di determinismo: io non sarei affatto così sicuro dello stretto rapporto causale fra buona Costituzione e buona politica: nelle cose sociali il determinismo non funziona, anche se capisco che per ognuno l’ambito delle cose che studia diventa centrale (è un po’ quello che accade agli economisti, i quali pensano che presi alcuni provvedimenti di politica economica l’uomo d’incanto diventa più buono e la società “armonica”). Il ragionamento non regge poi nello specifico perché le “vestali della Costituzione” potrebbero obiettare (già sento le loro voci) che la Carta è sì “la più bella del mondo” ma è rimasta inattuata, disattesa, che va finalmente compiuta e messa in pratica. Quindi, anche per loro la buona Costituzione, se messa in grado di esprimere tutte le sue potenzialità, genererebbe la buona politica. Un ragionamento questo della “costituzione tradita” o “non realizzata” che si intreccia con la retorica di bobbiana memoria delle “promesse non mantenute” della democrazia (quasi che la democrazia possa non vivere per sua essenza se non in uno stato imperfezione o prosaicità).
Detto questo, i motivi sostanziali che mi portano a diffidare delle “vestali” e a credere che sia non solo opportuno ma necessario apportare modifiche non di facciata alla nostra Costituzione sono quelle che ho espresso in una nota qualche mese fa, e che qui ripropongo. C’è qualcosa di paradossale, osservavo allora, nella difesa, “senza se e senza ma”, della Costituzione da parte di un vasto fronte. Intellettuale più che politico. Arrivare poi a dire che la nostra Costituzione sia “la più bella del mondo” è una sciocchezza, o peggio denota malafede. La nostra Costituzione, credo, sia superata dalla storia, soprattutto nell’essere sostanzialmente democratica più che liberale, persino con forti tratti socialisti (e non si tratta del socialismo liberale). Quando poi si ripete essa sarebbe non solo viva e vegeta, ma anche non realizzata e finalmente ora da realizzare si rasenta il ridicolo perché sembrerebbe che sia proprio a quei tratti comunisti (o benecomunisti come ora si dice) che si faccia riferimento. Detto questo, io non solo non sono un critico in astratto e in assoluto della Costituzione italiana, ma anzi ne riconosco i meriti storici altissimi. Mi spiego. Le Costituzioni, di cui fra l’altro si può anche fare a meno (basta vedere il caso della Gran Bretagna), nascono di solito ad un cambio di regime, quasi a suggellare per iscritto i nuovi valori che si vogliono affermare o, come pure si dice, il “nuovo patto costituente” che lega i cittadini. Così, è stato anche per la Costituzione italiana, che doveva in qualche modo sancire non solo il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, ma anche la presa del potere da parte del vasto fronte delle forze che si erano opposte al fascismo. Fronte vasto soprattutto dal punto di vista delle ideologie di riferimento, dai comunisti ai liberali conservatori per intenderci. Sembrava un’impresa quasi disperata far nascere una Costituzione da forze così eterogenee, e per giunta nella maggioranza non liberali (i due partiti maggiori, il comunista e il democratico cristiano, concepivano fra l’altro la democrazia in modo radicalmente diverso). Eppure, il miracolo fu fatto. La Costituzione italiana è l’esempio di un alto compromesso, di quelli che raramente la politica raggiunge. Ma che d’altro canto, va aggiunto di questi tempi, solo essa può raggiungere: i costituenti erano “tecnici” in senso solo secondario o derivato, avendo ognuno una forte appartenenza politica che non impediva però loro di cercare in buona fede e raggiungere un punto di equilibrio fra le rispettive posizioni. Il “segreto” era probabilmente nell’eccezionale qualità umana, diciamo così, dei costituenti, che non avevano bisogno di definirsi o essere definiti “saggi” perché lo erano di fatto. Erano una vera “classe dirigente”, anche se o proprio perché non partecipavano a quei convegni sul tema che oggi vanno tanto di moda. E sapevano per lo più che le Costituzioni nascono, vivono, si trasformano e muoiono nella storia: in una parola, non possono essere imbalsamate come le “vestali” tipo Zagrebelski, Rodotà o Barbara Spinelli vorrebbero fare. Ecco, è la storia l’elemento non considerato fino in fondo nel discorso sulla Costituzione. Data la situazione del tempo in cui la nostra fu stesa e promulgata, quelle forze in campo e quei rapporti politici, si può dire che risultato migliore forse non si poteva ottenere. Ma sono passati sessanta anni da allora, e il mondo è corso velocemente. Il quadro geopolitico, economico, sociale, culturale soprattutto, è completamente cambiato. Quelle forze politiche non esistono più. E, soprattutto, non esiste e non è più riproponibile in una democrazia occidentale quella visione del mondo che era propria di una delle forze che più ispirarono la Costituzione. il Partito comunista. La Carta andrebbe perciò, a mio avviso, riscritta, cambiata profondamente, anche nella parte dei principi e dei valori. Certo, all’orizzonte non si vede una “classe dirigente” in grado di farlo, persone sagge (non “saggi”) che antepongano la ricerca del compromesso al proprio interesse di parte. Ma questo è un altro discorso. Ed è credo il vero nodo della questione.
I “talebani” de “la Costituzione non si tocca” perché “è la più bella del mondo” sono fra i massimi responsabili della strada rovinosa lungo la quale sta procedendo da anni l’Italia; e, negli ultimi tempi, con una velocità tale da far temere che sia impossibile riprendere il controllo del veicolo. Come il pullman precipitato sull’autostrada di Avellino, per intenderci. Lo dico senza animosità, come costatazione di un fatto e senza accusare nessuno: è così, che ne siano consapevoli o meno, qualunque siano le loro intenzioni, anche le migliori.
Ho trovato di incontrovertibile buon senso, nella sua semplicità, quel che ha detto Enrico Letta alla Camera nel corso dell’ultimo dibattito sulla fiducia. La prima parte della Costituzione fissa traguardi ambiziosi e importantissimi; per avvicinarli (lasciamo stare il raggiungerli) sono necessarie istituzioni che garantiscano la stabilità e l’efficacia della azione di governo. Oggi questa istituzioni non ci sono; ed è per questo motivo che si deve riformare la seconda parte della stessa Costituzione; altrimenti anche le meravigliose affermazioni contenute nella prima parte scadono a fastidiose e frustranti litanie.
E’ noto che sono trascorsi ormai 30 anni dalla prima commissione parlamentare per le riforme costituzionali e istituzionali (la “Bozzi”) Ai motivi che spingevano verso le riforme già da tempo, si aggiunse nel 1993 il passaggio al sistema maggioritario e l’accantonamento di quello proporzionale. Per me tale novità obbligava a risistemare tutto l’edificio costituzionale (definito nella seconda parte). Basti pensare alla perdita di significato di tutte le maggioranze qualificate e di garanzia previste nel testo del 1948 a fronte della alterazione maggioritaria. E’ un dato che non autorizza a contestare la “legittimità” delle assemblee parlamentari così costituite (come fa il prof. Becchi) ma certo obbliga a ridefinire moltissimi istituti e procedure.
Per quanto mi riguarda cominciai da quel momento a denunciare l’aprirsi di una “falla costituzionale” e a sollecitare gli interventi per chiuderla. Un ventennio non è stato sufficiente per farlo. E’, senza dubbio, la colpa più grande di un ceto politico – vecchio e nuovo – arrivato oggi all’esaurimento e drammaticamente alle prese con l’impossibilità di assicurare all’Italia e agli italiani una decente governabilità.
A questo punto una cosa mi sembra assolutamente certa: nessuna leadership, nessuna nuova classe dirigente potrà affermarsi se non risolverà il problema costituzionale. E, in modo complementare, chi si mostrerà capace di farlo assumerà forza e prestigio decisivi.
Ho apprezzato particolarmente gli interventi di Corrado Ocone e del prof. Pasquino.
Io però ripartirei dalla riscrittura della prima parte della Carta, sui suoi principi fondamentali.
Quello del lavoro, deve essere un diritto acquisito, inequivocabile?
Quale deve essere il rapporto tra libertà e uguaglianza nell’articolo 3?
Che dire dei rapporti Stato-Chiesa?
Solo la Repubblica deve essere primo garante della cultura, delle ricerche scientifiche e tecniche?
Covatta, il comma 22 e gli amis de la Constituion.
COMMA 22. Il M5S, gli amis de la Constituion (giuristi, preti, etc.) difendono la legittimità della Costituzione o la legalità costituzionale? Ma non è neppure questo, in fondo. Serve uno scarto: l’art. 138 Cost. è una norma giuridica? Forse. In tal caso, però, è bene prepararsi ad una logica ancor più infernale di quella del «comma 22» che Covatta ricorda. Ad esempio: l’art. 138 si applica anche a se stesso? Si può modificare l’art. 138 attraverso il procedimento formativo previsto dall’art. 138? L’art. 138 fa parte della Costituzione o si riferisce alla Costituzione, o le due cose insieme (sarebbe, cioè, linguaggio e meta-linguaggio al contempo)? L’ideologia giuridica chiama tutto questo «autoriferimento» (self-referring Laws). Si può revisionare la norma sulla revisione? L’art. 138, nel disciplinare il procedimento di revisione costituzionale, disciplina anche la revisione di se medesimo? Alf Ross lo ha definito a puzzle in constitutional Law. Si potrebbe chiamarlo, senza problemi, art. 138, comma 22.
CONTRO-MOVIMENTO. È possibile disporsi per pensare in modo non giuridico l’art. 138 Cost.? E se l’art. 138 non fosse una norma giuridica? E’ possibile pensare una procedura di revisione/modifica della Costituzione in modo non giuridico? O forse il discorso giuridico si è a tal punto imposto da non consentire di pensare una «procedura» se non in termini di «procedimento legale», di procedimento ordinato secondo regole giuridico-formali, procedura come norma? Si può pensare una «procedura» attraverso un discorso di lotta, anziché giuridico?
TEMPORALITÀ DEL 138. Un passo indietro, perché l’interrogativo appare quasi impossibile. L’«autoriferimento» (self-reference, sui-référence) è logicamente implicato nell’art. 138. Ma non è forse reso disponibile, possibile, da un presupposto di natura non-logica? Non ha a che vedere con un certo pensiero della temporalità riferito alla Costituzione ed alla sua modifica/revisione? Modifica, revisione, rimandano ad un determinato movimento del diritto: la legge dispone per l’avvenire. Così anche l’art. 138, perché la nostra Costituzione è sempre stata pensata a partire dal primato dell’avvenire nel tempo. Punto fermo, sia chiaro, del dibattito in Costituente: «La Costituzione è affidata all’avvenire» (Ghidini), «la Costituzione deve […] fare, più che al passato, riferimento al futuro» (Laconi). Il senso della Costituzione, in altri termini, è determinato a partire dall’avvenire: per questa ragione la Costituzione dev’essere «attuata», «realizzata», «impegna» il futuro, risponde alla logica del «farsi legare». Il pensiero giuridico dell’autoriferimento dell’art. 138, anziché essere una «necessità logica», non è forse conseguenza del riferimento temporale, della temporalità che si articola nella Costituzione?
“ROVESCIAMENTO”. Questa «temporalità» fu, probabilmente, una necessità storica (difesa correttamente da Togliatti contro Calamandrei, rivendicando l’importanza del carattere programmatico degli articoli dedicati ai «diritti sociali»). Ma oggi? Ha davvero senso continuare a pensare la Costituzione come avvenire?
Primo movimento: dovremmo, piuttosto, pensare la Costituzione come a-venire, come pensiero della promessa (secondo Derrida: «democrazia a venire», e non «democrazia futura». Non dunque «idea regolatrice», o norma programmatica, non rinvio ad un presente-futuro, ma piuttosto pensiero dell’evento inanticipabile e «critica politica militante senza fine»).
Secondo movimento: pensare la Costituzione in modo realmente rivoluzionario, significa rovesciare la logica della temporalità presente nella nostra Costituzione. Solo il marxismo ha tentato questo contro-movimento, rispetto all’idea di costituzione come «progetto di forma politica, con la quale il presente cerca di legare i tempi futuri». Così Lenin: «vale la pena di registrare solo ciò che è stato conquistato in modo effettivamente durevole» (Conquistato e Registrato, 5 marzo 1919). Poi, più diffusamente, Stalin: «la Costituzione non dev’essere confusa con un programma. Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve ancora essere ottenuto e conquistato nell’avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente. Il programma riguarda soprattutto l’avvenire, la Costituzione riguarda il presente» (Sul progetto di Costituzione dell’U.R.S.S., 25 novembre 1936).
“SPOSTAMENTO”. Occorre fare attenzione. La differenza di cui parla Stalin, il principio conquistato e registrato, non è un semplice “rovesciamento” del nostro concetto di Costituzione (un semplice rovesciamento del rapporto presente / futuro). Questa differenza segna, infatti, il passaggio da un discorso giuridico ad un discorso di lotta a proposito della Costituzione. Questo «scarto» non si limita a “rovesciare” i riferimenti temporali, a “capovolgere” l’ideologia giuridica (come se, nel marxismo, «dittatura del proletariato», «legalità rivoluzionaria» fossero espressioni o concetti giuridici). Esso, diversamente, crea un nuovo oggetto teorico, un concetto di Costituzione che non è più pensabile in termini giuridici, ma soltanto di lotta. Forse, allora, anche l’idea di «democrazia a venire» (e non futura) non è pensabile se non in questo «spostamento».
FATTO E PROMESSA. Il discorso sulla Costituzione pronunciato da Stalin ripete continuamente: «questo è un fatto, non una promessa». La “logica” della Costituzione dipende dai fatti, da ciò che è conquistato o perduto nella lotta (non al giuridico, alla norma, pertanto, al «dover essere»). Se c’è, parallela ad essa, una logica della promessa, essa non può che essere a-venire, non può che riguardare «un’altra storicità», come scrive Derrida, che si affianca a quella della Costituzione: storicità che permetta di «aprire l’accesso a un pensiero che afferma la promessa messianica ed emancipa in quanto promessa: in quanto promessa e non in quanto programma» (è, cioè, la parte spettrale del marxismo). In questa doppia logica (del fatto e della promessa, della lotta e dello spettro) non è più in questione l’«attuazione» o la «modifica» della Costituzione. Non c’è più avvenire (futuro che sarà presente, presente-futuro) ma a-venire, non procedura ma conquista, non norma ma registrazione.
REDUCTIO AD STALINUM. Non si tratta qui, evidentemente, di marxismo o stalinismo. Si tratta, diversamente, di disporsi a pensare quel contro-movimento cui s’è fatto cenno: si dà, è possibile, un pensiero non giuridico della «revisione» costituzionale? O esso è già-da-sempre controllato, significato, disciplinato dalla logica dell’autoriferimento, dal «comma 22»? Come si passa dal discorso giuridico al discorso di lotta (una precisazione: il discorso di lotta è il discorso politico solo se quest’ultimo si pensa a partire dal “rovesciamento” di Foucault: «la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi»)? È questo l’interrogativo centrale, è questa possibilità di “passaggio” – è la possibilità di pensare, di rendere pensabile questo scarto – che meriterebbe di essere discussa come la reale questione costituzionale.
Ieri Gianfranco Ravasi rammentava, su “Il sole 24 ore”, l’origine del termine “bigotto” che verrebbe dal giaculare senza sosta l’invocazione “by God, by God”.
Spiace per la gloriosa Fiom – che a guardarsi intorno avrebbe ben altro da fare – ma la manifestazione di sabato ci è parsa una giaculatoria di massa. Se non altro per i lunghi – e noiosi – decenni di inutili declamazioni sulla “piu bella del mondo”.
Come in tutte le giaculatorie è comparso anche qualche slancio mistico, incarnato se ci si passa il termine, da un simpatico presidente emerito della Corte Costituzionale. L’idea di un insieme di norme come “corpo mistico” ci pare nuova, ma non sarebbe venuta in mente nemmeno ai più rigorosi esegeti del testo normativo (quello sì) più bello del mondo, che era il codice napoleonico. Per non parlare dell’Imperatore, che a sentir parlare di mistica delle norme avrebbe mandato la Guardia.
Veniamo a qualche argomento apparentemente più fondato, che è quello di chi sostiene che tutta la Costituzione italiana ha come presupposto il sistema proporzionale e quindi non c’è altra via per modificarla che il 138.
Ora in questa argomentazione ci sono un errore, una fallacia, una trappola.
L’errore consiste nel fatto che non è possibile che un testo costituzionale sia fondato su qualcosa che non contiene e che nessun interprete autorizzato ha statuito che contenesse. Ovvero: fu intenzione dei costituenti non accogliere in costituzione la proporzionale, anche se, in quel momento, conveniva a tutti. Sarebbe come dire che la Costituzione francese “presupponeva” il generale de Gaulle.
Appunto “in quel momento”. Qui si trova la fallacia: pensare che condizioni storiche particolari (l’equilibrio di Yalta) dettino norme eterne. Molto semplicemente: tra il 1946 e il 1948 non si sapeva come sarebbe andata a finire. Oggi ci vorrebbe un sistema che garantisse l’equilibrio tra due cose: governabilità e rappresentatività. Ma molti fanno finta- per demagogia o per stupidità- di essere ancora nel 1948.
Da questa distorsione deriva la trappola. siccome la “strada maestra” è il 138 e quindi solo il Parlamento può fare modifiche nessuno sa più di quale parlamento si tratti. Quello del porcellum va bene? O, a rigore di logica, solo un Parlamento eletto dalla proporzionale pura? Trappola atroce visto che tutti quelli che ci sono caduti, da Grillo a Travaglio, sembrano contenti.
Sembrano.
Ci vorrebbe qualcuno che dicesse qualcosa di simile a ciò che disse Roosevelt quando cadde il proibizionismo, a seguito di una procedura costituzionale da lui stesso avviata: “E’ venuto il momento di una bella birra ghiacciata”.
Temevo di avere esagerato nell’accostare l’articolo 138 al comma 22, ed i promotori della manifestazione di sabato alle più insulse burocrazie. Ora però (“Corriere della Sera” di oggi) mi conforta Antonio Ingroia, che si augura che “questo Parlamento di nominati a causa di un sistema elettorale incostituzionale consenta ai cittadini di esprimersi”, facendo “mancare la maggioranza di due terzi in modo che si possa chiedere in tempi brevi il referendum confermativo”. Uno pensa che Ingroia voglia il referendum sul progetto di riforma della Costituzione, e potrebbe obiettare che la legge ora all’approvazione del Senato già lo prevede, a prescindere dal quorum con cui la riforma verrà approvata. Invece no: Ingroia vuole il referendum proprio sulla deroga al 138. Proprio cioè per riconsegnare al “Parlamento di nominati a causa di un sistema elettorale incostituzionale” il potere esclusivo di riformare la Carta. Viene voglia di citare Flaiano e l’insuccesso che dà alla testa. Ma forse è meglio la saggezza del proverbio cinese sul dito e sulla luna. Perchè per essere stupidi non c’è bisogno di avere subito un insuccesso: è una qualità innata, che non preclude eventuali successi.