L’America first potrebbe venire intesa come una radicale negazione della politica americana degli ultimi settanta anni (il periodo postbellico) e l’inizio «di un nuovo corso tutto da costruire»: così si esprime Giuseppe Mammarella nel suo ultimo libro, preparato e scritto alla Green Library della Stanford University, «aperta in tutte le sue funzioni fino all’una di notte», come fa notare l’autore con una punta di invidia1.
L’analisi di Mammarella prende le mosse dal momento della nascita dello Stato nord-americano e delinea a grandi linee il processo di formazione delle sue strutture sia sul piano delle istituzioni che su quello della politica. I due grandi raggruppamenti politici americani ai quali siamo ormai abituati andarono modellandosi già alla fine del Settecento, durante il grande dibattito sulla nascita della Costituzione (scritta nel 1787 ed entrata in vigore nel 1789), di cui gli 85 articoli del Federalist (usciti fra il 1787 e il 1788), pubblicati con lo scopo di illustrare la nuova Costituzione e convincere gli oppositori a votarla, costituiscono non solo un documento prezioso, ma quasi gli incunaboli della democrazia politica moderna americana e occidentale.
Le due maggiori forze, il cui nome si andrà delineando nel tempo, furono da una parte quelle del federalismo hamiltoniano, legato al concetto di Stato nazionale con una forte capacità di orientamento della politica e fornito di tutti gli strumenti necessari, da una banca centrale ad un esercito nazionale ed alla capacità di dirigere anche i grandi interessi industriali, mercantili e finanziari; dall’altra parte la corrente fortemente connessa alla vita democratica dei singoli Stati, alle deliberazioni locali contro gli interventi dello Stato centrale e contro la sua voglia di direzione politica centralistica: una corrente legata alle istanze dei farmers, i grandi proprietari terrieri che di fatto basavano gran parte della loro attività sull’esistenza di uno schiavismo ritenuto inamovibile. Nel periodo successivo andò plasmandosi il principio della leadership di partito, basato sulla forte corrispondenza leader-masse: «Il partito americano non propone un’ideologia, tanto meno una Weltanschauung. Il partito americano si batte per le issues, per i problemi della gente, cercando, con ricorso alle mediazioni e agli espedienti, più o meno confessabili, di risolverli».
Durante la guerra civile (1861-65), nella quale il nord risultò vincitore sul sud schiavista, gli Usa furono guidati dal presidente repubblicano abolizionista Abraham Lincoln, il quale scrisse e fece approvare il XIII emendamento alla Costituzione, che aboliva la schiavitù. Una lunga serie di presidenti repubblicani governerà fino alla fine dell’Ottocento un paese in tumultuosa crescita, prendendo gran parte delle decisioni politiche nelle smoke-filled rooms, cioè in sale a porte chiuse, piene di fumo. In reazione a tale politica sempre più ristretta e di vertice si andò diffondendo il metodo delle primarie, nato negli Stati del sud ed estesosi poi a quelli del nord. Ma «sarà Franklin Delano Roosevelt, con la grande crisi, a interrompere bruscamente la serie delle presidenze repubblicane». Roosevelt, presidente fra il 1933 e il 1945, riuscirà a costruire un «blocco storico tra le forze sociali in crescita nella società americana: le minoranze, quella nera, quella ebrea e quella italiana, la categoria degli intellettuali […] la classe lavoratrice dell’industria con i sindacati e una parte della classe media». In Europa il modello rooseveltiano del New Deal verrà salutato con molto favore, ma anche in America rimarrà un punto di riferimento per gli intellettuali liberal.
Dopo un quarantennio, negli anni Settanta del Novecento il modello democratico entra in crisi, anche per l’effetto negativo dell’azione della New left, un’esperienza legata alla contestazione giovanile degli anni Sessanta che mai avrebbe dato luogo alla nascita di nuove realtà politiche. Cominciano ad emergere nuove categorie intellettuali di stampo conservatore, nuovi stili politici, soprattutto negli anni Ottanta, con Reagan. Al vecchio elettorato conservatore si affiancheranno i neoconservatori e la nuova destra religiosa. Ma i partiti, alla fine del Novecento, si mostrano in crescente affanno e spesso non riescono a contenere le frange estreme che vanno sorgendo in tutta l’America: in parte per il forte impatto dei problemi locali, il mutato finanziamento della politica, l’ormai «generalizzata pratica delle primarie». I partiti si trovano quindi in concorrenza con una molteplicità di gruppi organizzati e di movimenti fiancheggiatori, che comunque esprimono una grande vitalità della società americana: «A far politica, oltre al partito sono varie associazioni, fondazioni e riviste, ma soprattutto una miriade di lobbies che […] non rappresentano solo interessi economici piccoli o grandi, ma anche single issues, problemi particolari di carattere sociale e politico».
Un ulteriore problema per i partiti è dato dalla pratica ormai diffusa delle primarie, spesso determinate più che dai militanti di partito, dai fiancheggiatori, come quelli del Tea party. Infine Internet ha reso molto più facile e diretto il contatto dei candidati con l’elettorato: «Nel passato era il partito il maggiore canale di comunicazione con l’elettorato, oggi sono la televisione e il web». Tuttavia i partiti americani si vanno trasformando e assumono nuove prerogative e nuovi profili: i repubblicani cercano di dare al partito un’immagine forte ed un programma articolato (il contratto con l’America), i democratici hanno rafforzato gli organi di partito all’interno del Congresso e cercano di ristabilire l’autorità del centro sulla periferia. Inoltre è stato notato come il partito democratico venga percepito a destra «come un pericoloso dilapidatore di una ricchezza nazionale non più illimitata», mentre il partito repubblicano, spinto su posizioni oltranziste da un movimento come il Tea party, mantenga comunque una notevole capacità di attrazione, pur divenendo sempre più estremista: si tratta di «una democrazia inceppata»?
All’America brillante degli anni Cinquanta, attiva e ricca di messaggi inneggianti alla democrazia e alla libertà, ha fatto seguito un paese in difficoltà
Così era sembrato dopo l’elezione di Trump alla presidenza. Ma non è uno scenario apocalittico che rivelano le elezioni di mid-term del 6 novembre scorso. Molti elettori, in precedenza non partecipanti, sono tornati a votare, portando i democratici a conquistare la maggioranza alla House of Representatives. Come hanno fatto i democratici a rilanciarsi? Probabilmente una migliore organizzazione politica, un progetto meglio definito, dei buoni candidati, dei referenti sociali ben individuati li hanno rimessi in gioco: ma i repubblicani hanno mantenuto il Senato, migliorando anzi la propria posizione. Anche se Trump ha aumentato la propria presenza al Senato non solo nel numero ma nella composizione degli eletti, molto più trumpiani che nel precedente Senato, dovrà ora fare i conti con una House in cui non ha la maggioranza e dove vedrà contestati molti disegni di legge proposti nel prossimo futuro. I democratici hanno compreso le mancanze evidenti nel vecchio progetto di Hillary Clinton, ed hanno cercato di individuare le sponde sociali su cui basare il proprio contrattacco politico.
Da una parte hanno puntato ad una maggiore e più qualificante presenza di donne e in particolare di donne di colore, di musulmane e di native americane: ma anche sulla presenza di tanti personaggi liberal provenienti da importanti aree urbane. In tal modo hanno realizzato un mix molto forte di vari gruppi sociali di minoranza (ma che, nell’insieme, sono prossimi ad avere la maggioranza nella società americana) e di ceti sociali urbani che ha portato a tale notevole risultato. Il che dimostra anche come ci sia un’America delle diversità, dell’apertura e del confronto che prende le proprie distanze dalla chiusa narrativa trumpiana. Trump, una volta superate indenne le mid-term elections, conferma forse la sua capacità di persuasione e addirittura di carisma: bisogna quindi ammettere che egli, «a differenza di molti altri che si conformano alle regole e allo stile del processo politico, ha una percezione delle attese e degli umori della gente che, come lo hanno aiutato a vincere, potrebbero aiutarlo a governare».
La grandezza dell’America consisteva, oltre che nelle grandi idee politiche che hanno modellato il mondo dopo la seconda guerra mondiale, nella sua potenza militare, economica, culturale. Si tratta di una fase che si è forse conclusa, «e l’errore principale di Obama”, scrive ancora Mammarella, “è stato quello di non averlo capito o comunque di non avere reagito, per spirito di conservazione e timidezza». Sicuramente Obama è stato molto criticato, alla fine del suo mandato. All’uomo che con il suo Yes We Can aveva suscitato speranze palingenetiche «viene imputato di non essere riuscito ad aggregare un blocco sociale del tipo di quello creato da Roosevelt per far fronte alla crisi del 1929, un blocco che pure era potenzialmente esistente al momento della sua elezione nel 2008». Il suo messaggio politico è stato recepito più in Europa che nel nord-America. All’America brillante degli anni Cinquanta, attiva e ricca di messaggi inneggianti alla democrazia e alla libertà, ha fatto seguito un paese in difficoltà e gli americani che hanno votato Trump lo hanno fatto con la segreta speranza che «il 45° presidente della storia americana riporti il paese alla grandezza di un tempo». Trump ha appunto denunciato quest’impasse e la sua America First è l’impegno a fare ritornare l’America a quei livelli, liberandola da eccessivi impegni internazionali, da vincoli militari e commerciali, in nome di un nazionalismo pragmatico e attento ad un riposizionamento dell’America nel mondo.
1 G. MAMMARELLA, America first. Da George Washington a Donald Trump, Il Mulino, 2018, pp. 227.




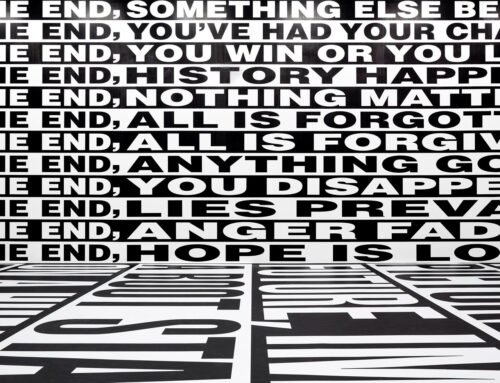
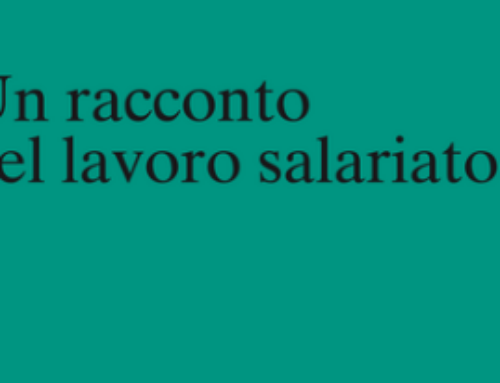
Scrivi un commento