Gian Primo Cella
In questi ultimi due decenni abbiamo scritto molto su Gino Giugni[1], sulla sua sapienza teorica nel rifondare il diritto del lavoro, sulla sua capacità di dotare le relazioni industriali di una adeguata struttura disciplinare, sul suo impareggiabile ruolo di “politico del diritto”: come lui stesso amava definirsi, rifiutando quella definizione di “tecnico del diritto” che riteneva venata di subalternità, anche se sapeva quanto tale definizione fosse per i giuristi l’apprezzamento più ambito. Ma certo, tecnico o politico che fosse, si è rivelato sicuramente un grande “pratico”, perché la tecnica avrebbe potuto condurre distante dalla vita civile se non fosse stata applicata a questioni pratiche decisive per gli assetti sociali. Nessuno può dimenticare le capacità di Giugni nel destreggiarsi nella impostazione, e talvolta nella soluzione, di problemi complessi come quelli legati alla regolazione dei cottimi e della job evaluation (nei lontani anni sessanta), alle questioni dei licenziamenti e dei trattamenti di fine rapporto o alla indennità di contingenza derivata dal meccanismo di scala mobile. Un grande teorico-tecnico-pratico animato da una controllata ma costante passione civile, sempre modulata dall’understatement e dall’auto-ironia. Nell’insieme una personalità, quella di Giugni, che merita di essere collocata non solo fra gli ispiratori, ma anche fra i realizzatori della vita repubblicana nell’ambito degli assetti pluralisti, quelli che corrispondono alle aspirazioni (e alle ambizioni) liberal-democratiche dell’intero XX secolo (ovvero il secolo industriale), e che trovarono una definizione esemplare nella Costituzione del 1948. Una collocazione che gli spetterebbe insieme, che so, a Costantino Mortati o a Pasquale Saraceno e a pochi altri. Un posto che gli sarebbe riconosciuto più esplicitamente se non gravasse sul lavoro, sui sindacati, sulla contrattazione collettiva, la condizione – quasi la condanna – della “storia minore”.
In questo intervento dovrei esprimere qualche osservazione sul rapporto fra Giugni e il movimento sindacale italiano, e sul suo coinvolgimento nelle politiche di concertazione. Due ambiti, lo vedremo subito, che sono in stretto collegamento fra loro: Giugni non avrebbe potuto svolgere un ruolo decisivo nelle politiche di concertazione se non avesse goduto di un rapporto del tutto particolare con i sindacati, e per molti aspetti anche con le associazioni imprenditoriali. La concertazione, si sa, non può essere del tutto imposta alle parti sociali, e il consenso, più o meno facilitato, è un requisito indispensabile per il suo successo. In questo caso vorrei però accompagnare queste osservazioni con qualche ricordo personale: un procedere che non sempre si segue in modo esplicito, ma che mi sembra adatto a questa occasione. I ricordi derivano dalle esperienze di collaborazione con Giugni nella seconda metà degli anni novanta nell’ambito della “Commissione di garanzia” per gli scioperi nei servizi pubblici, e nella Commissione incaricata dal presidente del Consiglio Prodi nel settembre 1997 per valutare il funzionamento del protocollo del luglio 1993 nel primo quadriennio di attività, nonché per proporre alcune linee di modifica.
Da questi ricordi traspare un riconoscimento indiscusso per il suo ruolo e per il suo equilibrio, nonché il prestigio che emanava, in forme semplici se non dimesse, dalla sua persona o dai suoi interventi. Un riconoscimento e un prestigio che potevano assumere una vera portata istituzionale nella regolazione dei conflitti prevista dalla legge del 1990 (novellata nel 2000) sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La portata di questo raro prestigio fra le parti sociali veniva subito colto dai commissari. Come sappiamo, i meccanismi di funzionamento della Commissione e le connesse procedure non erano del tutto efficienti, anche per la mancata definizione legislativa della rappresentatività dei soggetti collettivi, nonché per le intemperanze di alcuni sindacati (allora, debbo ammettere, a parte gli autonomi, più della Cisl che della Cgil), o per le reticenze e inadempienze dei datori di lavoro. Talvolta le procedure mostravano barocchismi eccessivi, e di conseguenza la regolazione dei conflitti poteva risultare incerta e difficoltosa. In questi casi si rivelavano spesso risolutive una telefonata di Giugni, o una sua lettera di invito di poche righe. E’ stata una esperienza sorprendente, che non si dimentica.
Il riconoscimento e il prestigio (e in alcuni momenti, come nel varo dello Statuto, anche la visibilità) ci dicono molto sul ruolo e sull’operato di Giugni
Il riconoscimento verso Giugni emerse anche nel corso delle audizioni alle parti sociali che la Commissione per la valutazione dell’accordo del 1993 tenne nell’autunno del 1997, con una certa formalità, segnalata fra l’altro dalla sede: la sala verde di Palazzo Chigi, dove nel luglio 1993 venne firmata l’intesa fra governo, sindacati, imprenditori, dopo non pochi contrasti. Fatte salve delle obiezioni su aspetti del tutto marginali, unanime fu il consenso delle parti (rappresentate dai segretari generali o dai presidenti) sui contenuti del protocollo, sulle sue esigenze di adeguamento dopo i primi anni di attività (specie sulle scadenze temporali dei rinnovi contrattuali), sul metodo stesso della concertazione. La mia impressione di allora, e che mi sento di confermare dopo un ventennio, è che questo consenso fosse certo provocato dall’indubbio rilievo dell’accordo, un vero e proprio basic agreement del tipo di quelli funzionanti da molti decenni nei paesi scandinavi, ma fosse anche imputabile alla fiducia riposta nel ruolo e nella figura di Giugni. Delle dinamiche che nell’Italia di oggi potrebbero sembrare quasi mitologiche. Peccato, come ebbe modo di ammettere lo stesso Giugni, che il documento conclusivo (e propositivo) della Commissione, accettato e condiviso dalle parti, venne subito archiviato, per poi essere timidamente riscoperto (con sorpresa) dalle stesse parti, travolte dall’abbandono del metodo concertativo in una litigiosità crescente (specie intersindacale) e insicure nella adozione delle necessarie procedure di innovazione delle relazioni contrattuali, come quelle riguardanti l’introduzione di (controllate) clausole di apertura dei contratti nazionali, del genere proposto proprio dal documento della Commissione. Ma allora Giugni, in declino anche fisico, si era ormai ritirato dalla scena.
Il terzo ricordo e la terza esperienza risalgono all’incontro che questa Commissione ebbe, nel tardo autunno 1997, con l’allora ministro del tesoro Carlo Azeglio Ciampi nel suo ufficio al ministero delle Finanze in via XX settembre (anche qui i luoghi contano!). Ad intervistare il ministro Ciampi andarono assieme a Giugni alcuni componenti della Commissione: oltre a chi scrive, mi sembra Biagi, D’Antona e Tosi. Il colloquio-intervista con Ciampi durò un paio d’ore, mai interrotto da telefonate o da altri interventi esterni, e anche questo sembra oggi mitologico. Quello che mi colpì fu l’ammirazione, e l’affetto riconoscente, che Ciampi mostrava nei confronti di Giugni: una riconoscenza nata soprattutto dal successo del protocollo realizzato nel luglio 1993. “La cosa più importante che abbia condotto a termine nella mia vita politica”, ci disse Ciampi, mentre ci ricordava che la mattina successiva alla firma dell’accordo ricevette una telefonata di congratulazioni dal Cancelliere Kohl nella quale, ammirato, gli disse che in Germania, nonostante le sue intenzioni, non sarebbe mai riuscito a portare in porto una impresa del genere. La via dell’ingresso nella moneta unica europea era aperta, e la concertazione aveva fornito un apporto decisivo.
Il riconoscimento e il prestigio e, in alcuni momenti (come nel varo dello Statuto) anche la visibilità certo ci dicono molto sul ruolo e sull’operato di Giugni, tuttavia è necessario soffermarsi, per tracciare meglio il quadro, sulle sue capacità di comprendere e interpretare le molteplici culture sindacali italiane che hanno continuato ad operare nel secondo dopoguerra italiano, appena attenuate ed avvicinate dai periodi (non lunghi) di unità sindacale, nell’assenza effettiva di un modello nazionale di sindacalismo, del tipo in qualche modo accreditabile alle altre grandi esperienze sindacali, da quella britannica, a quella tedesca, a quella americana. Una capacità di comprensione che aveva avuto origine, anche questo lo conosciamo bene, avendone Giugni parlato più volte nel lontano 1951, durante il soggiorno americano, alle lezioni di Selig Perlman alla “scuola del Wisconsin”. Credo che allora non esistessero al mondo luogo e momenti migliori per lo studio del movimento sindacale, della sua storia, della sua logica, della sua pratica.
La tradizione istituzionalista fondata da Commons e ereditata da Perlman era più che mai attiva, e il sindacato americano stava entrando nel suo ventennio di massimo splendore, dopo le promesse del New Deal e le istituzioni del Wagner Act, e nonostante i ripetuti tentativi di ridimensionamento del labor power e di alcune sue deviazioni (a partire dalla legge Taft-Hartley del 1947). Questa origine e questa mirabile anomalia di un grande giurista che riceve la sua formazione fondativa, una vera Bildung, in discipline non giuridiche, spiegano molto sull’opera e sulla carriera di Giugni, ma soprattutto ci forniscono la chiave per cogliere la natura della sua capacità di comprensione della teoria e della pratica sindacale.
Al ritorno dagli Stati Uniti Giugni arrivò con una missione importante per la cultura italiana (sinistra inclusa) così digiuna di studi sindacali, ovvero la traduzione dell’opera principale di Selig Perlman A theory of the labor movement, che apparve nel 1956 per i tipi della Nuova Italia, con una sua lunga e perfetta introduzione. Le parole finali di questo scritto erano semplici e chiare, ma provocatorie per la tradizione politica italiana: l’esperienza della scuola del Wisconsin “costituisce una pietra miliare nella ricerca di un metodo critico nello studio della peculiarità del fenomeno sindacale, come fatto non identificabile con la politica, e capace di porsi in modo autonomo come fattore di progresso istituzionale e civile” (p.37). Bastava così, il cammino del pluralismo era tracciato. Il libro fu riedito nel 1980[2], con l’introduzione originale e con una nuova premessa che riconfermava appieno il primo scritto introduttivo, ma con un passo finale che introduceva un motivo chiave per cogliere il pensiero di Giugni e per introdurci verso i percorsi della concertazione, come rapporto fra sviluppo e regolazione delle autonomie rivendicative: “Dall’esito di questo rapporto più che dal confronto tra modelli teoretici dipende la risposta all’interrogativo sulla compatibilità tra socialismo e pluralismo; ed è l’interrogativo che vien da porsi, nella lettura di un testo che può a pieno titolo annoverarsi tra i primi classici del pluralismo” (p. XV).
Nei decenni del dopoguerra si confrontavano (talvolta in modo aspro) due culture sindacali, quella “della classe o delle politiche di classe”, che animava l’esperienza della Cgil, e quella “del pluralismo e della contrattazione” espressa dalla Cisl[3]. La cultura della Cgil proponeva la rappresentanza sindacale della classe e del lavoro (ben distante dal labor americano), si sentiva a disagio nel rappresentare gli affiliati, gli iscritti all’organizzazione, non riusciva a interpretare la contrattazione collettiva come strumento principe per la risoluzione (sia pure temporanea) di problemi di regolazione delle condizioni di lavoro, interpretandola piuttosto come un mezzo (accanto ad altri) per la affermazione delle rivendicazioni o per la promozione del lavoro. La contrattazione era sottovalutata come istituzione autonoma in grado di assicurare il rapporto fra i gruppi sociali rappresentati del sindacato e l’insieme delle trasformazioni della società.
Giugni aveva sia questa capacità di conciliazione fra culture spesso contrapposte, sia queste ambizioni riformatrici che nascevano dalla combinazione fra pluralismo e socialismo
Con questa cultura si misurava la Cisl, soprattutto nei primi decenni del dopoguerra e negli anni decisivi dell’avvento e della diffusione della industrializzazione di massa, nonché delle politiche di sviluppo industriale del Mezzogiorno (con gli interventi decisivi delle imprese a partecipazione statale). E’ la cultura che ritrova alimento e ispirazione nelle esperienze del sindacalismo britannico e nordamericano, ben più che nelle tradizioni del solidarismo cristiano-sociale, mantenendo di queste solo le aspirazioni associative. La contrattazione non è solo lo strumento principe dell’azione sindacale, apprezzato ed esaltato come metodo non rinunciabile in alcun senso: ma è soprattutto una via per integrare una parte (il lavoro e la sua condizione) nel tutto (la società e il suo sviluppo industriale). Entro questa cultura l’industria è ritenuta come il solo contesto nel quale può affermarsi il sindacalismo moderno. Non c’è dunque da meravigliarsi come sia stato in questo ambito culturale a ritrovarsi almeno in parziale sintonia il giovane Giugni, di ritorno dagli Stati Uniti[4]. Come segnale di questa intesa possiamo ricordare come sia stato lo stesso Giugni a tradurre e a fare pubblicare nel 1960 sulla rivista dell’Ufficio studi della Cisl Politica sindacale il saggio del 1954 di Otto Kahn-Freund (l’altro suo grande maestro), I conflitti tra i gruppi e la loro composizione, che delinea in modo magistrale il metodo di regolazione delle relazioni industriali pluraliste. E proprio nello stesso anno verrà pubblicato il contributo dottrinario fondamentale di Giugni sul nuovo diritto sindacale, la Introduzione allo studio della autonomia collettiva. Il rapporto con la Cisl non fu senza tensioni, come ai tempi dello Statuto, osteggiato dalle componenti più avverse all’intervento legislativo, ma molte omogeneità culturali restarono.
Era abbastanza evidente che in quei decenni centrali del periodo repubblicano, diciamo il trentennio 1960-1990, per pensare ad una affermazione di tutto il movimento sindacale italiano e del suo ruolo nelle relazioni pluraliste tipiche delle società industriali occorreva non solo ricercare una mediazione fra le due culture sindacali in competizione, ma anche proporre forme di coinvolgimento accettabili con le istituzioni pubbliche nelle politiche di sviluppo, fossero o meno all’insegna della programmazione o della politica dei redditi. Giugni aveva sia questa capacità di conciliazione fra culture spesso contrapposte, sia queste ambizioni riformatrici che nascevano dalla combinazione fra pluralismo e socialismo, e se si vuole dalla riscoperta della tradizione del socialismo riformista italiano e dei suoi risvolti sindacali. E’ così che attraverso l’operato di Giugni riscopriamo gli apporti decisivi forniti dalla cultura sindacale socialista/riformista nei lunghi decenni del dopoguerra, impersonata da alcuni grandi dirigenti (nella Cgil e in parte nella Uil), con uno dei quali, Giacomo Brodolini, Giugni ebbe stretti rapporti dopo il passaggio di questo agli incarichi di governo. Una cultura che, debbo riconoscerlo, noi studiosi del movimento sindacale e delle relazioni industriali non abbiamo considerato o valorizzato abbastanza, tutti presi come eravamo fra l’innovazione che sembrava connaturata alla presenza della Cisl, e la mobilitazione rivendicativa che sembrava appannaggio quasi esclusivo della “grande” Cgil, specie sotto la guida di un sindacalista straordinario come Di Vittorio. Si scoprirà poi come lo stesso Di Vittorio fosse più sensibile alla cultura socialista, di quanto ci si potesse attendere seguendo gli schemi interpretativi consolidati.
E’ questa la cultura addirittura può essere fatta risalire al “programma minimo” turatiano, e che plasmava la concezione e l’opera della prima Cgdl. In essa emerge il rispetto e la valorizzazione del pluralismo, senza alcuna pretesa egemonica e con accenti che ricordano i tratti migliori del laburismo britannico. Da questo carattere generale emerge un apprezzamento non strumentale della contrattazione collettiva, del tutto anomalo nella cultura dominante della Cgil e semmai tipico della cultura Cisl, con la connessa ricerca del rapporto con le riforme. Di conseguenza le relazioni con le politiche pubbliche non sono viste solo in chiave conflittuale e competitiva, ma anche con taglio propositivo nell’accettazione degli obiettivi comuni di sviluppo economico e sociale.
Una considerazione positiva dell’industria, della sua evoluzione e delle sue esigenze, e una connessa fiducia nello sviluppo produttivo, costituiscono quasi una costante della cultura sindacale socialista. Di questa cultura Giugni fu un efficace interprete, valorizzando anche la sua esperienza di collaborazione con il mondo delle imprese a partecipazione statale, negli anni migliori dell’Intersind e dei centri dirigenti dell’Iri[5]. A questa esperienza va fatto risalire quel protocollo Intersind-Asap del 1962 che venne concluso con la firma di tutte le federazioni dei metalmeccanici, e che, mirando alla costruzione di un sistema e di una struttura della contrattazione con un elevato grado di istituzionalizzazione, può essere considerato come la vera pietra fondativa delle moderne relazioni industriali italiane. Queste mi sembrano le origini lontane della partecipazione intensa di Giugni alla logica e, come sempre, anche alla pratica delle politiche di concertazione. Politiche che possiamo definire come null’altro che delle forme di pluralismo organizzato e controllato, con un ruolo decisivo delle istituzioni pubbliche nel regolare in modo strategico gli interessi interdipendenti degli attori sociali.
Negli ultimi anni, ritirato dalla vita pubblica, provato fisicamente, Giugni non scriveva quasi più: ma aveva mantenuto una memoria vivissima, sostenuta da un sorprendente ricco archivio personale.
E’ partendo da queste doti che Giugni ci ha lasciato un dono prezioso, due libri-intervista[6] che, condotti in modo perfetto dai curatori, ricostruiscono non solo la sua formazione e il suo operato come politico riformatore, ma anche la sua tranquilla (sempre però ironica e talvolta caustica) determinazione nel perseguire i suoi obiettivi di riforma. Nel primo testo è il cammino della concertazione, come sviluppo coerente del pluralismo, ad essere posto al centro delle vicende degli ultimi due decenni del secolo passato. Nel secondo si accentuano i caratteri autobiografici, permettendoci di scoprire quella passione per il socialismo democratico (controllata ma intensa) che forse avevamo tutti nascosto dietro le “maschere” del grande giurista e del grande riformatore pratico. Nel testo sulla concertazione (del 2003) ritroviamo appieno quello stile di azione e di interpretazione di Giugni che lo porta a descrivere con rara efficacia le vicende della crisi dei rapporti concertativi e della coeva vicenda, per molti aspetti assurda, dell’art.18 dello Statuto: è stata proprio l’interruzione delle politiche di concertazione “con la rinuncia e il rifiuto di proseguire sulla strada degli accordi triangolari che ha reso possibile uno scontro così ‘retrogrado’ come quello sul diritto alla reintegra nel posto di lavoro dopo l’ingiusto licenziamento” (p.93). Con sobria ma non nascosta polemica nei confronti di quanti (osservatori e attori economici o politici) hanno sostenuto l’opposto, ovvero che è all’abuso delle politiche concertative che andrebbero addebitate le difficoltà e le tensioni nella regolazione del rapporto di lavoro. E’ un giudizio, e un monito, che avrebbe mostrato tutta la sua rilevanza, nelle vicende del decennio successivo, jobs act compreso. Rileggiamo queste memorie, rimpiangeremo Giugni ma capiremo meglio quel che è successo.
Riferimenti
[1] Ricordo come esempio il numero 2/2007, del Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali in occasione dei suoi ottant’anni, con scritti di Aaron, Blanc-Jouvan, Cella, Ghera, Grandi, Grossi, Rodríguez-Piñero, Romagnoli, Treu, Weddenburn.
[2] S. PERLMAN, Per una teoria dell’azione sindacale, introduzione di G. Giugni, Edizioni Lavoro, 1980.
[3] Sono costretto allo schematismo, sgradevole, da ragioni di spazio. Per una analisi più approfondita rimando al mio Culture sindacali e modelli di relazioni industriali, in Storia del lavoro in Italia. Il novecento 1945-2000, a cura di S. Musso, Castelvecchi, 2015.
[4] Sui rapporti fra Giugni e la Cisl, si veda il documentato, ma forse troppo diplomatico, saggio di Mario Grandi, Gino Giugni e l’esperienza associativa della Cisl nel suo primo ciclo storico (1950-1970), in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n.2/2007.
[5] Per cogliere i tratti riformatori di questo mondo, invito a rileggere gli scritti di Felice Balbo degli anni (1960-62) in cui fu direttore del Centro Iri per lo studio delle funzioni direttive aziendali in Opere 1945-1964, Boringhieri, 1966. In essi ritroviamo i fondamenti etico-filosofici di quelle che saranno in seguito le politiche di concertazione.
[6] Mi riferisco a G. GIUGNI, La lunga marcia della concertazione, a cura di P. Ferrari e C. La Macchia, Il Mulino, Bologna, 2003, e a G. GIUGNI, La memoria di un riformista, a cura di A. Ricciardi, Il Mulino, 2007.


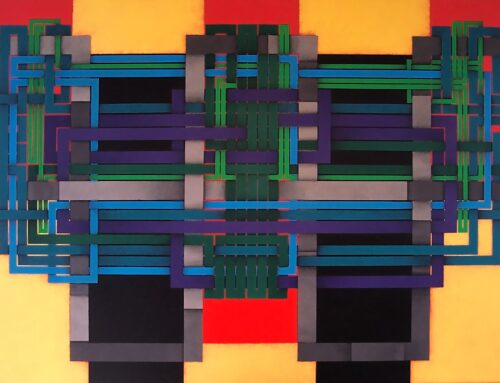



Scrivi un commento