Evoco il caso della ragazza 14enne di Bologna che rifiuta il velo per una riflessione più generale. Negli anni ’60 e ’70 non pochi, a sinistra, consideravano questioni come il divorzio estranee ai problemi dei lavoratori. Eppure oggi il nome del socialista Loris Fortuna resta indissolubilmente legato alla legge che consente e regola il divorzio e alla vittoria referendaria del 1974, da tutti ritenuta un vero spartiacque nella storia politica italiana.
Ecco: dinanzi alla vicenda della famiglia emiliana, originaria del Bangladesh, che pare che imponesse (più in nome della tradizione che della fede religiosa in senso stretto) alla ragazza il velo e uno stile di vita “non occidentale”, si può provare un senso di lontananza. O magari ci si può sentire emotivamente partecipi (memori forse delle famiglie autoritarie di un tempo), senza tuttavia coglierne appieno i risvolti e la politicità. Sì, perché in ballo troviamo la possibilità per le varie comunità etniche o religiose di coltivare la propria cultura, e nel contempo le libertà e i diritti del singolo. Un esempio delle nuove sfide che attendono coloro che hanno a cuore le ragioni del rispetto e della differenza. Come raggiungere un equilibrio tale da garantire differenza e rispetto sia agli individui, sia ai gruppi? E ancora: come far sì che la comunità offra delle chance piuttosto che restringere le opportunità e i margini di libertà delle persone?


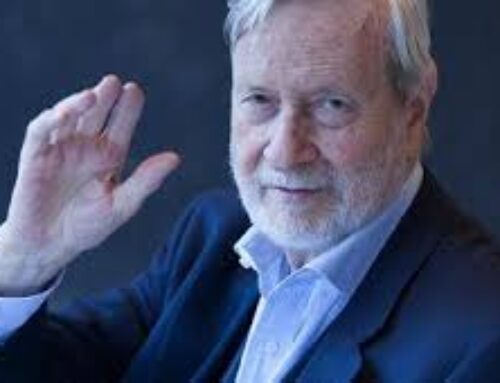



Quando ero ragazzo (molti anni fa, ma non all’epoca di Matusalemme) una mia compagna di liceo, di famiglia altoborghese, venne sequestrata in casa dai genitori perchè si era invaghita di un giovanotto di basso ceto. Qualcuno denunciò il fatto all’autorità giudiziaria, e ai genitori fu tolta la patria potestà. Erano tutti cattolici osservanti (anche il pretendente sgradito). E non ci fu bisogno di nuove leggi o di approfondite meditazioni per regolare questo piccolo “scontro di civiltà”.