E’ difficile accedere a questa idea: ma esiste una posizione secondo cui la riduzione del numero dei parlamentari intende lanciare un sasso riformista nel pantano della transizione italiana. La questione però esiste. Gabriele De Rosa forse esagerava a definire “infinita” la transizione appena nel 1997 (anche se la faceva retroagire a prima del crollo del sistema dei partiti governativi)[1]. Ceccanti e Vassallo nel 2004 si ponevano il problema di come porvi fine[2]: ed in effetti erano dieci anni dalle elezioni in cui debuttava Forza Italia e non c’era più mamma Dc. Nel mio piccolo la definivo nel 2015 ormai interminabile ed eterna[3].
Da allora sono passati altri cinque anni: ed essendo terminati gli aggettivi inerenti al trascorrere del tempo si può comprendere che qualcuno metta in discussione il fatto, anche perchè nessuno ne parla più nei termini di una transizione. Siccome però all’inizio eravamo tutti d’accordo[4], forse non dovremmo soprassedere all’idea, e dovremmo concludere che viviamo nella più lunga transizione istituzionale che un paese abbia mai sperimentato in Occidente. Chiarirne la natura e le caratteristiche appare fondamentale. Prima ancora però occorre ricordare che vivere in una transizione così a lungo è di per sé un serio problema: perchè offusca consapevolezza e strumenti per comprendere come possa funzionare un ordine. Inoltre una transizione offre elementi di incertezza per molti ordini di fattori che non possono non ripercuotersi anche sulle prestazioni di un sistema.
In via del tutto preliminare affermare che siamo in una transizione vuol dire riconoscere che al posto dell’ordine in crisi o senz’altro morto non ne è nato un altro che lo rimpiazzi. Si possono avere pochi dubbi sulla circostanza che, perduti insieme un sistema partitico e certi equilibri istituzionali nel triennio 1991-1993, l’Italia non abbia più avuto un regime politico degno di questo nome, e si trascina in una sorta di non-luogo (esattamente nel senso dell’espressione utilizzata da Augé), dove la vita scorre e accadono cose buone e meno buone, ma manca uno spazio definito per fini specifici, con conseguenze non piccole in termini anche identitari. Ma c’è di più. Vivere, come si dirà meglio in seguito, con una Costituzione insidiata dal nuovo che avanza ma che non si compie, tra spinte e controspinte, senza che principi di struttura capaci di affermarsi né sostituendo né rilegittimando, come il giurista positivo pretende, quelli che ci sono, comporta confusione nel sistema e nella società.
Si può affermare senza timore di smentita che dal 1993 abbiamo avuto e abbiamo solo cosiddetti partiti, abbiamo avuto diversi sistemi di (codesti cosiddetti) partiti, e più sistemi elettorali di quante ne abbiamo avuti nel resto della nostra storia unitaria. Ma un regime proprio no: quanto semmai il tentativo di introdurre una Costituzione materiale in contrasto con quella formale e comunque incapace di affermarsi definitivamente sia sul piano materiale che, come al limite sarebbe auspicabile, formale. Questo tentativo rappresenta la vera sostanza – ambigua – della “seconda Repubblica”. Ogni nuovo ordine che mira ad affermarsi ha un vocabolario, una sintassi e una semantica. Volendo provare una reductio ad unum vengono in mente alcune espressioni, pur inevitabilmente non del tutto sovrapponibili in quanto ciascuna ha un proprio retroterra ed è parte di una dicotomia concettuale, ma che sono però largamente degli equivalenti funzionali una dell’altra: la democrazia maggioritaria, la democrazia governante, la Repubblica dei cittadini, il neo-parlamentarismo, ed altre ancora che citeremo in seguito.
Per chi scrive, più tecnicamente, è il progetto di una “democrazia immediata”, e il suo disegno può essere spiegato in modo molto semplice: interpretare la democrazia rappresentativa prevista in Costituzione come se fosse una democrazia diretta. Ciò implica, inevitabilmente, misconoscere la democrazia rappresentativa: quindi delegittimarla e comunque smarrirne le ragioni. Non poco, visto che la democrazia rappresentativa è un asse fondamentale della nostra Costituzione, ritenuto peraltro irrivedibile. Possibile? E se sì, come è stato possibile arrivare a ciò?
Come la democrazia rappresentativa e pluralistica, innervata di intermediazione, fu l’antitesi della “democrazia totalitaria” fascista, allo stesso modo la “seconda Repubblica” è stato il tentativo di ribaltare un’esperienza ormai estenuata
In principio bisogna tener presente che la “prima Repubblica” fu una poderosa partitocrazia: cioè uno Stato di partiti, declinazione inevitabile delle moderne democrazie, ma particolarmente granitico e pervasivo. Essa riuscì a lungo a produrre e garantire una forte legittimazione al sistema politico e istituzionale, e uno sviluppo economico, sociale (e, forse in misura minore, civile), anche se in forme peculiari. Gli storici (cito per tutti Lanaro e Craveri) parlano infatti diffusamente di uno sviluppo senza guida: e Cassese giunse a chiedersi in un noto pamphlet se esistesse un governo in Italia. Forse un governo no: ma era chiarissimo chi comandava, e Moro lo spiegò bene ai perplessi esponenti dell’amministrazione statunitense quando garantì che l’instabilità ministeriale endemica non costituiva affatto un problema, perché in Italia c’erano i partiti a garantire la tenuta del sistema.
Di quel sistema politico i partiti erano l’alfa e l’omega, i portatori della Costituzione (tranne il Msi), pronti a garantire e rispondere anche delle sue inattuazioni o cattive attuazioni. Quel regime ad un certo punto si inceppò, attorno alla fine degli anni ’60. Dopo la stagione dei grandi convegni e delle tentate autoriforme dei partiti, superata la via pan-politica del compromesso storico, la questione istituzionale emerse successivamente dalla fine degli anni ’70 nelle pieghe di un dibattito sulla riforma costituzionale, più o meno “grande”. Ma i partiti ormai erano sul banco degli imputati, e nel mondo si dibatteva da qualche lustro del “caso italiano”: anche se il paese nel decennio ’80 crebbe ancora al ritmo medio del 2,5% Pil all’anno. Qualcosa però si era rotto in quella costituzione materiale che integrava senza grandi contraddizioni (salvo che per qualche aspetto) quella formale. Dalla denuncia maraniniana della partitocrazia come regime chiuso e oligarchico in senso deteriore, a quella bassiana di aver lasciato il principe “senza scettro” (e al j’accuse pasoliniano del Palazzo e dell’ “Io so”), divennero pian piano senso comune le idee degli intellettuali, secondo cui lo scettro era solo stato preso in prestito, se non proprio rubato (e non solo quello).
Inutile ripercorrere le tappe di questo decadimento del sentimento partitico – e comunque della delegittimazione del sistema – presso la cittadinanza: che ovviamente all’inizio si manifestò in modo episodico e obliquo (tanto che la partecipazione elettorale restò quasi fino alla fine superiore al 90%, un dato ritenuto dai politologi patologico, ma per eccesso), poi sempre più diffuso, sistematico ed esplicito. Benché molti elementi deriverebbero da quell’analisi, più interessante appare comprendere cosa è venuto dopo, sapendo bene che il nuovo ha radici sempre nel vecchio, e che in questo misto di continuità e cesure è possibile recuperare qualche pezzo di analisi.
Come la democrazia rappresentativa e pluralistica, innervata di intermediazione, fu l’antitesi della “democrazia totalitaria” fascista (della verticalizzazione del potere, della demonizzazione del pluralismo partitico, del parlamentarismo e della rappresentanza liberale), allo stesso modo la “seconda Repubblica” è stato il tentativo di ribaltare un’esperienza ormai estenuata che – non lo dimentichiamo – ci portò ad un passo dal baratro nel 1992. La partitocrazia, per dire di una linea di continuità, ebbe in effetti qualcosa di onnipervasivo, alla fine vissuto (con le relative ipocrisie) come soffocante, che con qualche enfasi fu spiegata da Giuliano Amato in un memorabile discorso (21 aprile 1993, all’indomani dei referendum) con il mero passaggio dal singolare del fascismo al plurale.
Per la paura che la mancanza di alternanza producesse, come altre volte nella storia d’Italia, una crisi e un’alternanza di regime, si misero in piedi idee che, come una profezia che si autoavvera, accelerano una crisi di sistema
Si disse che occorreva passare dalla Repubblica dei partiti (Scoppola) alla “Repubblica dei cittadini ombra” (Pasquino, 1991), per superare quella che Duverger nel lontano 1968 aveva chiamato, riferendosi alla Francia, una “democrazia senza popolo”. Ma il popolo nei partiti, in Italia, c’era eccome. Non dobbiamo dimenticare che Duverger, con Burdeau, Vedel, Mendès France e tanti altri, lottò negli anni ’50 e ’60 non contro i partiti, che ritenevano irrimediabilmente declinanti, ma contro “la Repubblica dei deputati”, contro il centrismo e il trasformismo: tanto che Augusto Barbera, in una nota voce per la Treccani del 1991, avrebbe affermato (parlando di un passaggio determinante della III Repubblica, ma valeva ancora quasi cento anni dopo) che gli avvenimenti francesi contribuivano “a rendere non facile l’emergere di partiti in grado di assicurare quella disciplina che stava invece rafforzando, al di là della Manica, il regime di gabinetto”.
La centralità della soluzione istituzionale in Francia realizzò un ulteriore indebolimento dei partiti. In Italia il problema non era questo, perché i partiti erano forti (per quanto in crisi) e il trasformismo era inesistente, con le ideologie ancora relativamente forti e radicate. L’irresponsabilità della classe politica nella “prima Repubblica” operava su tutt’altro piano, perché su quello della responsabilità intesa come responsività e ricettività il sistema appariva fin troppo responsabile. Cominciò però ad andare per la maggiore l’idea che il cittadino fosse in balia di partiti che stavano in politica come al tavolo del poker, e non contasse nulla: che la delega era giocata irresponsabilmente e senza render conto. Analisi in parte fondata, ma non ci si chiese quanto fosse la mancanza di alternanza ad aver peso su tale piano, né si distinsero le cause esterne dell’assenza di queste condizioni da quelle endogene.
Per la paura che la mancanza di alternanza producesse, come altre volte nella storia d’Italia, una crisi e un’alternanza di regime (Sabbatucci, Salvadori), si misero in piedi idee che, come una profezia che si autoavvera, accelerano una crisi di sistema, sia pure nella permanenza della forma di Stato repubblicana: aprendo però una crisi anche costituzionale. In breve fummo sommersi da una marea di retorica antipolitica dalla quale non siamo più usciti. Nel 2007 Carlo Galli (La Repubblica, 10 aprile) ha affermato che la “storia della seconda repubblica – così sospettosa verso i partiti – ci sta insomma mostrando che in realtà una politica senza partiti è essenzialmente populismo, cioè ricettiva passività, oppure anonima antipolitica”. Da allora sono passati altri tredici anni, e quanto al populismo ne avremmo viste ancora delle belle, dall’elogio dell’incompetenza all’uno-vale-uno, alla democrazia dei clic.
La sensazione che fossimo alla fine di una stagione della democrazia speciale (ancora Craveri) determinò un passaggio improprio dalla contestazione a quei partiti alla contestazione ai partiti, e così fatalmente andava persa buona parte della pedagogia della politica. Protagonismi alternativi seri non se ne sono visti, e in anni più recenti ha preso piede perfino una retorica contro i corpi intermedi nota come la “disintermediazione”.
Ma la cosa più sorprendente di questo processo – e oggetto di questo saggio – è che il più pericoloso populismo della nostra storia repubblicana non è stata la retorica populista alla Giannini o alla Lauro (o alla Bossi, alla Berlusconi, alla Grillo che dir si voglia): ma il populismo istituzionale che ha pervaso, con rare eccezioni, l’intero sistema politico, su cui i populismi stessi della seconda Repubblica si sono basati. Nella prima c’era populismo in alcune forze politiche, ma si travasava quasi senza residui in scelte politiche demagogiche e clientelari. Ora no. Un continuo contrapporre democrazia vera e falsa, più o meno autentica; la Casta/il Palazzo e il popolo/la piazza; volontà popolare e parlamentare.
Distinguendo doverosamente le critiche alla partitocrazia (si pensi a Luigi Sturzo, Gaetano Salvemini, Panfilo Gentile Lelio Basso o Cesare Merzagora) dalle posizioni populistiche in senso proprio, le politiche istituzionali e costituzionali sono state un momento fondamentale per comprendere il fallimento del sistema. Che ci fosse necessità di una seria e non superficiale opera di manutenzione della Costituzione, anche in relazione alla forma di governo (con incisioni sulla forma di Stato) non è in dubbio. E’ che siccome da Calamandrei a Craxi il presidenzialismo vero ha sempre fatto pochissima strada, avanzava un armamentario, presentato come riformista, che mentre proponeva di cambiare il sistema pretendeva di anticipare il mutamento reinterpretando radicalmente la Costituzione, fino a produrre interpretazioni incostituzionali della stessa. Ciò ha determinato una lotta per la Costituzione, con posizioni anche contingenti e strumentali, che ha introdotto infinite fibrillazioni nel sistema e ha impedito, nella migliore delle ipotesi, alla politica di riprendere quella giusta forza che dovrebbe spettarle in una democrazia popolare.
Non meraviglia che la “seconda Repubblica” abbia segnato la subalternità della politica a poteri economici, governo dei giudici, cricche di affaristi, partitini personali e piccole oligarchie
Forse perfino ha contribuito a distruggere quel poco che era rimasto. Basti pensare a quante centinaia, se non migliaia, di volte nel dibattito politico è stato evocato lo spettro di un governo o di un parlamento “illegittimo”: e più in generale è stato contestato l’operato di organi costituzionali, poteri e alte cariche (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, magistratura, presidenti delle Camere) alla luce di un presunto tradimento o mancato adeguamento ad un mandato elettorale o per una mancata considerazione della “volontà” del popolo. Una delegittimazione quasi costante della politica e delle istituzioni fatta dalla politica e sovente dalle sedi istituzionali con argomentazioni limpidamente illiberali e non in linea con un’idea di democrazia costituzionale. E allora forse non meraviglia che – se la “prima Repubblica” è stata il primato, perfino esagerato, della politica su ogni altro potere e contropotere – la “seconda Repubblica” abbia segnato la subalternità della politica a poteri economici, governo dei giudici, cricche di affaristi, partitini personali e piccole oligarchie (la “partitinocrazia” di cui parlava Miriam Mafai), vincoli esterni presentati come necessità, scatti di umori popolari.
Può suscitare qualche perplessità descrivere le politiche istituzionali come la fonte principale dell’incapacità della politica di riprendersi un proprio spazio nell’arco di quasi trenta anni, e un campo di battaglia decisivo per il declino italiano. Ma non lo è se si pensa che quelle politiche istituzionali hanno prodotto o accelerato uno scadimento di uomini e di rendimento delle istituzioni, e che nel mettere i partiti in contrapposizione coi cittadini hanno prodotto l’unicum di una democrazia che vive senza partiti degni di questo nome. Il populismo è un’ideologia costituzionale, quella della democrazia populistica, in antitesi alla liberale: ed è anche una politica, la politica dell’antipolitica. Se si adotta il populismo recedono le altre ideologie e le altre politiche.
Se l’analisi è corretta il leit motiv sotteso a tutto il post-1993 è stata la centralità del corpo elettorale – o, più enfaticamente, del “popolo” – nel tentativo di creare una democrazia che non fosse mediata: ma con il risultato di delegittimare partiti, rappresentanza e istituzioni, a partire dal Parlamento ovviamente (e in quest’ottica va indubbiamente l’ispirazione oggettiva del quesito referendario sulla riduzione del numero dei parlamentari). Per battere questa strada ci si è nutriti di un poco invidiabile primato, frutto di una sindrome eccezionalista, trascinando nella seconda Repubblica una democrazia anomala (non “normale” secondo l’espressione di Galante Garrone poi resa popolare da D’Alema) che rimpiazzava le vecchie anomalie con nuove, con alcune convinzioni e una costante: essere sempre “diversa” e dover fare come gli altri, ma al tempo stesso deformando costantemente i modelli e gli schemi mentali altrui, per un miscuglio di mistificazioni opportunistiche, di ignoranza provinciale e di “primatismo” giobertiano.
Eccezionale era nella “prima Repubblica” la dinamica del sistema (bloccato), la forza dei partiti, la venerazione della Costituzione (sacralizzata), la longevità delle classi dirigenti, il sistema elettorale (basato quasi su tutti i livelli sulle preferenze, spesso plurime, per lo più sconosciute all’estero), il rapporto tra politica ed economia e magistratura. In sintesi: la manutenzione della Costituzione era fuori dall’orizzonte di una politica che si faceva garante dei necessari mutamenti sociali e controllava la gran parte delle risorse materiali e simboliche, e le classi politiche erano impunibili, o almeno restavano impunite. La “seconda Repubblica” è nata attraverso un indebolimento, anche comprensibile, di queste eccezionalità: ma si sono fatte strada altre anomalie. Sul primo dell’indebolimento dei partiti si pensi al nuovo codice di procedura penale, che contiene strumenti nuovi per mettere in riga i partiti e rende i pubblici ministeri protagonisti della scena pubblica; la riforma dei reati ministeriali; la drastica riduzione dello spazio concesso alle preferenze (a partire dall’abolizione di quelle plurime nel 1991); la revisione dell’immunità parlamentare; il ridimensionamento della mediazione partitica ai livelli locali attraverso le elezioni dirette (1993); l’abolizione dei finanziamento pubblico, che – sia pure sostanzialmente vanificata dalle distorsioni messe in opera dai partiti – ha un peso simbolico fortissimo e comunque prelude a distorsioni terribili in nome del “costo della democrazia” che danneggiano irrimediabilmente l’immagine dei partiti (è in quegli anni che prende piede l’espressione “Casta”).
Anziché prendere atto che il sistema elettorale è abbastanza neutro rispetto alla disposizione del sistema politico in assetti bipolari, si preferì guardare al bipartitismo di Westminster
Quanto alle anomalie, con la “seconda Repubblica” nasce un armamentario di strumenti privi di riscontri all’estero: elezioni dirette in contesti caratterizzati formalmente dalla fiducia delle assemblee, con clausole simul stabunt sumul cadunt (enti locali, regioni); premi di maggioranza; primarie praticate da chi le ha adottate per ogni genere di carica, anche istituzionale; liste lunghe bloccate per la selezione della classe politico-parlamentare; “divieto di ribaltone”. Tutte espressioni di una mistica maggioritaria che costituisce una grammatica sconosciuta non solo alle democrazie parlamentari, ma alle democrazie tout court nel mondo. Il sistema elettorale maggioritario veniva visto come la chiave per sbloccare un sistema politico che invece restava bloccato esclusivamente per scelta dei partiti (realisticamente dalle elezioni del 1987): con la conseguenza di sovrapporre maggioritario, bipolarismo ed alternanza in nome di una rivitalizzazione della sovranità popolare.
Anziché prendere atto che il sistema elettorale è abbastanza neutro rispetto alla disposizione del sistema politico in assetti bipolari, si preferì guardare al bipartitismo di Westminster, offrendo peraltro una lettura delle dinamiche idealizzata e distorta. Ma prima ancora – con il referendum del 1991 sulla preferenza plurima (le cui potenzialità furono malcomprese perfino dai riformatori) – si polverizzavano le correnti, che costituivano la vera base materiale del sistema, e con esse si disarticolarono nel giro di un paio di anni i partiti di massa. Detto per inciso, la sovrapposizione concettuale tra maggioritario e bipolarismo produce ancora oggi gravi danni: ed ogni discussione sulle leggi elettorali, permanente nel nostro paese, assume i toni di una disfida di tipo metafisico tra due tipi di mondi, due tipi di sistemi politici, nei casi peggiori due tipi di democrazie, maggioritaria e consensusuale-consociativa. Si pensi al modo in cui Lijphart veniva letto in Italia prendendo per oro colato e fresco teorie vecchie di quattro decenni (e tarate su segmentazioni di tipo linguistico, etnico, religioso). Maggioritario e proporzionale sono invece null’altro che due famiglie di formule per tradurre voti in seggi, non prive di rispettive suggestioni, opportunità e vincoli, ma non certo dotate di queste capacità taumaturgiche.
Ma il maggioritario “metafisico” non operava solo sul piano elettorale. Su quello della forma di governo si ripresero vecchie ricette circolate tra i riformatori democristiani (anche dorotei) dalla fine degli anni ’60 per sanare patologie serie dei livelli locali: e si arrivava alla legge del 1993 sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia. Quindi la spinta dal basso arrivò ad un livello politico con l’elezione diretta del presidente della Regione a partire dal 1999, passando attraverso le leggi elettorali regionali a premio nel 1995. Era l’affermazione del modello del “Sindaco d’Italia”, e in generale degli schemi mentali neo-parlamentari, che in realtà non erano e non sono parlamentari ma extra-parlamentari. Con due effetti: una pressione interpretativa sulla Costituzione rappresentativa e parlamentarista, e una disarticolazione dei livelli partitici locali, riorganizzati attorno agli eletti con effetti imponenti di risalita anche a livello nazionale.
Accedendo all’idea che il corpo elettorale “elegge” il governo si mette in opera un corredo retorico e comunicativo che forgia il senso comune del cittadino
Il sistema delle cariche monocratiche elette dai cittadini erano però la facciata esplicitamente presidenzialista di un sistema che trovava la sua costante nella costruzione pre-elettorale delle coalizioni, accompagnata dalla garanzia di una maggioranza (attraverso un premio) capace di realizzare un programma sul quale dovrebbe essere giudicata dai cittadini. Meglio, appunto, ma per ultimo, se guidate da un leader o un capo politico. Tale disegno non è mai stato dismesso, ma neanche realizzato con una conseguente revisione costituzionale (del resto problematica). Esso affonda le radici nelle riflessioni di autori come Galeotti, Pasquino e Ruffilli: che, in forme e con proposte diverse, intendevano osteggiare tanto le derive assembleari che le derive plebiscitarie (la cd. democrazia di investitura), e si adoperavano per dare maggior peso al voto dell’elettore sul piano della determinazione degli indirizzi, delle formule, e semmai della scelta degli uomini governi. Nasceva come democrazia di indirizzo e “governo di legislatura”, ma finiva in esiti di investitura (a livello locale e regionale) o in tensioni populistiche e plebiscitarie a livello nazionale.
Il tutto era immaginato entro una meccanica semplicistica – apparentemente di tipo Westminster – dove in una dinamica bipolare due coalizioni competono per avere il mandato del popolo e si alternano al potere sulla base della valutazione dei risultati dell’azione di governo. La quale dinamica, però, preservata in ogni modo e servita da interpretazioni ad essa coerenti, tradisce completamente le regole di base della forma di governo parlamentare:, basata sull’identità partitica, sui rapporti di forza tra i diversi partiti, sulla scelta parlamentare del governo (intermediata dal ruolo del Capo dello Stato, nel nostro ordinamento), e sulla sua revocabilità per far posto a soluzioni alternative ritenute più adeguate alle esigenze del momento. Considerando il bipolarismo un sostituto funzionale del bipartitismo si introducevano elementi di grave distorsione nel sistema: e il modello Westminster storico, con grave equivoco, veniva assimilato alle cd. neo-parlamentarismo. Nelle democrazie parlamentari prive di significative anomalie, invece, operano ordinariamente dinamiche bipolari: ed essendo le opzioni di formula in numero limitato esse vengono prospettate all’elettorato prima delle elezioni non nella forma di coalizioni pre-elettorali quanto di compatibilità da verificare poi alla luce della forza delle singole formazioni partitiche che costituiscono l’offerta politica. Accedendo invece all’idea che il corpo elettorale “elegge” il governo si mette in opera un corredo retorico e comunicativo che forgia il senso comune del cittadino: il quale nutre aspettative coerenti con tale modello, per cui il semplice funzionamento della logica parlamentare può essere vissuto come un tradimento del “mandato popolare”, anche perchè in effetti non può operare il rendiconto e la responsabilità secondo la visione semplicistica che viene offerta del modello democratico. Berlusconi, senza inventare nulla (se non il partito proprietario) ha interpretato correttamente questo modello populistico fino a considerare i sondaggi fungibili coi voti. La lettura monca e parziale dell’art. 1 Cost. (omettendo le “forme e limiti” della sovranità) crea una forte tensione sull’art. 67 Cost., in tema di libero mandato parlamentare, e sulle disposizioni che riguardano in generale la forma di governo, come i poteri del Presidente della Repubblica, andando a minacciare il modo d’essere rappresentativo-parlamentare del nostro sistema.
L’alternanza si ebbe, e in modo anche troppo sospettosamente pendolare, perché le coalizioni eterogenee che avevano unico fine quello di vincere e sconfiggere gli avversari non riuscivano a offrire decenti performance di governo
Se si condivide la chiave interpretativa, il momento fondante della costruzione del paradigma a livello nazionale fu il modo del tutto peculiare in cui venne interpretata la componente maggioritaria della legge elettorale del 1993, nota come Mattarellum: dove la rudezza del collegio uninominale e la consolidata cultura proporzionalistica dei partiti portava ad organizzare l’offerta politica nei collegi con schieramenti pre-elettorali spartendo a monte i posti in lista suddivisi in fasce di collegi in base al rischio, assistiti da accordi di desistenza con forze esterne alle maggiori coalizioni. A tale adattamento non si sarebbe mai dato corso in un’altra grande democrazia parlamentare in nome dell’identità partitica. Ma nel 1994 erano spariti quasi tutti i partiti storici. Tale esito però non si spiega compiutamente se non facendo cenno al clima di delegittimazione reciproca tra le parti politiche (i cleavages speculari antiberlusconismo/anticomunismo) che perpetuava irritualmente la guerra fredda e dava corpo ad un bipolarismo forzoso, ingessato e muscolare le cui cattive performance sarebbero state all’origine del crollo del sistema politico nel 2013. Quanto all’identità partitica, fino al 2005 divenne l’eccezione che un elettore potesse votare nel collegio un candidato del proprio partito in nome del superiore interesse della vittoria della coalizione: contribuendo sicuramente ad erodere sia l’appartenenza partitica, sia la fiducia nei partiti e nel sistema, tanto più che l’Italia vantava molte aree fortemente connotate in senso sub-culturale (a questo punto fortemente erose).
L’alternanza si ebbe, e in modo anche troppo sospettosamente pendolare (con “isocrona maestrà”, direbbe l’Eco del Pendolo) perché le coalizioni eterogenee che avevano unico fine quello di vincere e sconfiggere gli avversari non riuscivano a offrire decenti performance di governo. Il tentativo di predeterminare un vincitore e l’indebolimento delle appartenenze partitiche provocava (come del resto avviene in misura ancora maggiore ai livelli locali, a causa del magnete dell’elezione diretta) autentiche transumanze verso la coalizione o il candidato più in salute: il cosiddetto effetto bandwagon. In tal modo il livello nazionale si è ammalato di trasformismo, che ideologia e identità partitiche avevano fino ad allora tenuto lontano. Nel 1994, 1996, 2001, 2006, 2008, centro-destra e centro-sinistra si sono alternati con una crescente insoddisfazione degli elettori a lungo sottovalutata dal sistema politico: che, con un’autentica fuga dalla realtà ed un uso spregiudicato dei rimborsi elettorali metteva in piedi una inedita “partitocrazia senza partiti” (l’espressione è stata utilizzata da Massari e altri) veramente irresponsabile, ed infatti segnata da non pochi scandali e da estrema autoreferenzialità.
Consci quantomeno che le coalizioni caravanserraglio avevano stancato gli elettori, ci fu un tentativo di ristrutturazione del sistema politico con la effimera stagione dei partiti “a vocazione maggioritaria” (altro vecchio adagio duvergeriano): novità propiziata da Veltroni grazie alla sua condizione di probabile soccombente alle elezioni del 2008. Ma ciò era possibile perché nel 2005 una nuova legge elettorale, mutuata dalle esperienze locali, introduceva un premio di maggioranza. Nel 2006 si confrontarono due coalizioni monstre. L’Unione e la Casa della Libertà risultavano composte da circa venti soggetti ciascuna, molti dei quali a loro volta raccolti in cartelli o federazioni: e il grottesco che ne derivò portò nel 2008 a due grandi soggetti politici (il Popolo delle libertà e il Partito democratico), con forte spinta al cosiddetto “voto utile”. Nel conseguì un Parlamento che sembrava quasi risolto, con il canalizzarsi di quasi tre quarti dei voti sui due soggetti principali e la presenza di 4-5 gruppi parlamentari: ma si trattava solo della superficie.
I soggetti politici restavano cripto-coalizioni, l’astensionismo ormai era livelli allarmanti, una parte importante degli elettori non era rappresentata per l’operare degli sbarramenti: e il trasfughismo parlamentare riprese presto non meno forte di prima. La legislatura si concluse nella confusione più totale, dopo tre anni di crisi economica mal contrastata. Nè bisogna farsi ingannare, sul piano dei ritrovati istituzionali, dalla diversità dei sistemi elettorali adottati. Essendo il maggioritario inteso in senso “metafisico”, anche un sistema proporzionale tornava buono al progetto della “democrazia immediata” a condizione che sapesse garantire un vincitore “la sera delle elezioni” (un triste refrain parecchio in voga). Si trattava anzi di un perfezionamento del precedente sistema, cosa del resto resa evidente dal fatto che il premio di maggioranza tecnicamente opera come una sorta di maggioritario – dal cui tronco storicamente nasce come idea – su collegio unico nazionale, con assegnazione però dei seggi “a ragion veduta” (com’era, in forma diversa sia nella legge Acerbo che nella cd. legge truffa).
Il sistema veniva perfezionato non solo sul piano della garanzia di una maggioranza “certa”, ma anche del suo controllo: con la selezione del ceto parlamentare che rafforzava il potere delle segreterie dei quasi-partiti (in gran parte partiti personali, proprietari o fortemente oligarchici), con il ricorso a lunghissime liste bloccate, e in misura spropositata alle pluricandidature, rimpiazzando le più artigianali elezioni paracadutate dei collegi uninominali (del resto possibili anche con la lista bloccata) e il più modesto ricorso alle pluricandidature. La mobilità parlamentare però proseguiva per la continua composizione e scomposizione di gruppi e i mutamenti di leadership, e si registrava un ulteriore calo costante della qualità del ceto politico e un forte allontanamento dei parlamentari dai territori.
Non si comprende come una tale situazione potesse essere rappresentata ancora nel 2011 (ad esempio da Augusto Barbera) come positiva e di oggettivo progresso istituzionale, per quanto non del tutto risolta: va da sé, si intende da una revisione costituzionale che la sanzionasse. Invece non sorprende affatto che in quei mesi questo secondo sistema di “partiti” e l’intero bipolarismo sia imploso su se stesso, sotto il peso di indegne e inqualificabili prove delle due coalizioni (centro-sinistra, 2006-2008, e centro-destra, 2008-2011). Un crollo certificato dal ritorno di un “governo tecnico”, frutto dell’impotenza dei partiti sia sul piano del governo che dello svolgimento dei più responsabili compiti del sistema, come avrebbe acclarato l’elezione del Presidente della Repubblica nel 2013. A conclusione di questa fase (2005-2011/13) restano, quale alta testimonianza, due memorabili interventi del presidente Napolitano: in un caso, alla nascita del governo Monti, a difesa delle prerogative del Parlamento e facendo strame della dottrina del “mandato popolare”; nell’altro, nel discorso della rielezione, in una reprimenda di inusitata durezza con cui si chiedeva ai partiti e alla classe politica uno sforzo straordinario di autoriforma e si tornava sulla necessità di formare, a legislatura appena iniziata, un governo in Parlamento con parole che meritano di essere riprese: “Il fatto che in Italia si sia diffusa una sorta di orrore per ogni ipotesi di intese, alleanze, mediazioni, convergenze tra forze politiche diverse, è segno di una regressione, di un diffondersi dell’idea che si possa fare politica senza conoscere o riconoscere le complesse problematiche del governare la cosa pubblica e le implicazioni che ne discendono in termini, appunto, di mediazioni, intese, alleanze politiche. O forse tutto questo è più concretamente il riflesso di un paio di decenni di contrapposizione – fino allo smarrimento dell’idea stessa di convivenza civile – come non mai faziosa e aggressiva, di totale incomunicabilità tra schieramenti politici concorrenti”. Parole come pietre su una seconda fase della Repubblica costruita per umiliare i partiti.
Da allora siamo in una sorta di transizione della transizione
Da allora siamo in una sorta di transizione della transizione. Fino al 2013 il modello basato sulle coalizioni pre-elettorali era indiscusso: e soprattutto i governi privi di una legittimazione elettorale (l’espressione è tecnicamente impropria, ma ci si riferisce in particolare ai governi Dini, D’Alema I, D’Alema II, Amato; in particolare i primi due, che rompevano l’idea del mandato) erano stati aspramente contestati con strascichi e veleni durati a lungo. Successivamente, ad esito di questo macroscopico fallimento istituzionale e sistemico, il clima è in parte cambiato. La nascita del governo Renzi ad esempio non è stata tanto contestata con la violenza con cui fu attaccato il governo D’Alema, quanto piuttosto sul piano della coerenza personale tra le dichiarazioni, subalterne al pensiero unico, di dover andare alla presidenza del Consiglio dalle elezioni, e i fatti successivi, che resero consigliabile un rapido cambio di rotta.
Però in un sistema privo di un baricentro e di regole consolidate può accadere che la decadenza di un’idea fino ad allora molto fortunata – il governo “eletto” dal popolo – si accompagni con il trionfo di un partito, il Movimento 5 stelle, integralmente fondato su premesse istituzionali populistiche (contrapposizione tra popolo ed élite, accettazione della “dottrina del ribaltone”, democrazia diretta ed elettronica, etc.), con l’importante novità del rifiuto programmatico di far parte di qualsivoglia coalizione, sia pre-elettorale che post-elettorale. Una posizione questa al tempo stesso succube del mandato popolare (rigettato nella forma della coalizione pre-elettorale), ma anche della logica parlamentare, con una conventio ad (auto-)excludendum che però non è stato possibile ribadire di fronte al clamoroso risultato del 2018 (32,8% dei voti, 35% dei seggi) che ha imposto ai Cinque stelle di formare un governo parlamentare con un partito concorrente alle elezioni, la Lega (Conte I): mentre la situazione di crisi venutasi a determinare e un istinto di autoconservazione ha portato rovesciarlo nel suo opposto, con il partito diametralmente contrapposto alla Lega (Conte II).
E siamo così all’oggi. Tutti parlano della parola passe-partout “crisi”: del sistema, del paese. Nessuno si interroga nell’ottica di una transizione su un partito nato dal nulla e senza mezzi materiali che è diventato subito il primo partito politico italiano, con il 25% dei voti e per giunta senza togliere un voto all’astensione, cresciuta ulteriormente e di molto (-5% rispetto al 2008; così come è ulteriormente cresciuta di un 2%, arrivando al 73% nel 2018). Un evento clamoroso. Partito populista senza residui che si forma su tutti i luoghi comuni della “seconda Repubblica” e a cui spetta, per contrappasso, di farsi parte protagonista delle più estreme prestazioni di duttilità dei sistemi parlamentari, dando vita alla spericolata piroetta del governo Conte II senza neanche mutare il Presidente del Consiglio.
Da dove si riparte? Naturalmente non sono mancati argini a queste derive, senza i quali la crisi politica e istituzionale si sarebbe aperta in una conclamata crisi costituzionale e di regime. Si è detto dei mandati di Napolitano. La stessa Corte costituzionale nella sua opera di garanzia a tutela della Costituzione ha espunto espressioni significative del modello della democrazia immediata: dalla condanna del premio di maggioranza all’italiana, all’eccesso di pluricandidature, alle liste bloccate chiuse lunghe, al surrogato funzionale del premio di maggioranza, quel ballottaggio di coalizione previsto dall’Italicum che, ennesima anomalia italica, ha cercato di trasporre sul piano nazionale la logica del collegio uninominale interpretato all’italiana. Si riparte da un sistema che in qualche modo ha tenuto, sia pure riportando con gravissimi danni.
A che punto siamo? Se alcuni eccessi sono stati espunti e alcune “dottrine” sono state severamente stigmatizzate, resta un’idea distorta secondo cui la governabilità sia innanzitutto stabilità, se non inamovibilità (come per le elezioni locali e regionali): mentre è ben più complessa cosa. Resta l’idea che il bipolarismo non sia una soluzione tendenzialmente fisiologica (e i processi in atto ne sono una ulteriore riprova), ma debba essere difeso e preservato con lo strumento di coalizioni pre-elettorali: e attraverso questa idea si può leggere in controluce molta parte del dibattito in corso sulla legge elettorale. Un tratto determinante sarà appunto il modo in cui si organizzerà l’offerta politica alle prossime elezioni: se su liste coalizionali o su liste partitiche. Il modo d’essere della prossima legge elettorale – ma soprattutto, dovrebbe essere chiaro, il modo in cui sarà interpretata – sarà fondamentale.
Un punto centrale del discorso, ben lontano dall’essere stato affrontato, riguarda la rilegittimazione dei partiti presso la cittadinanza, che passa attraverso una nuova immagine ma anche da regole e garanzie che fungano da limiti ma al contempo offrano opportunità. Di questa rilegittimazione la nascita del Partito democratico intendeva essere un punto di inizio (succedendo a due soggetti politici che avevano declinato il nomen partito, e si parlava di svolta politica, culturale e morale nella vicenda italiana): ma ambiguamente perpetuava alcuni limiti di quella stagione, come l’uso estenuato delle primarie, l’idea di una vocazione maggioritaria senza premesse reali, e certe suggestioni verso la democrazia immediata (si deve al governo a guida Pd l’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti). Finita la fase faunistica e arborea del nostro sistema politico restano in vita quattro o cinque soggetti grandi o medi e un numero notevole di rassembleament in cerca d’autore. Non pochi sono i partiti personali e proprietari, ma il sistema appare più aperto di quanto non lo fosse dieci anni fa.
Sul piano delle regole, i partiti dovrebbero avere uno statuto più netto, e – solo a questo punto – risorse finanziarie e organizzative (servizi, ad esempio) più certi. Il partito italiano più organizzato ha tutti i suoi funzionari, circa 140, in cassa integrazione. D’altro canto di pluralismo e democrazia non se ne vede molto nei partiti. Ma avere forme organizzative funzionanti, democratiche e plurali (anche se di un pluralismo piuttosto asfittico) è il primo passo per rafforzare un pluralismo culturale interno e un’identità partitica esterna. Quest’ultima non può consistere in qualche misura di bandiera, ma occorre una ideologia che oggi non può prescindere dall’inquadramento in soggetti politici europei, anch’essi peraltro piuttosto evanescenti. Un modello alla tedesca, centrato sul fiancheggiamento di serie Fondazioni che in questi lustri non hanno mai smesso di operare, potrebbe essere un modello perseguibile per animare il dibattito pubblico, formare culturalmente e politicamente nuove generazioni di militanti e cittadini, aiutare i partiti nella formazione delle agende.
Ma prioritario appare liberare la stessa classe politica, culturalmente assai debole, di dottrine insulse. Queste dottrine comportano fallimenti politici e naufragi elettorali, perché i fatti (e talvolta anche le norme) hanno la testa dura e la realtà offre repliche difficili da ignorare. Se ciò è avvenuto è proprio perché negli ultimi decenni l’intero sistema politico (salvo sparute filiere politico-culturali) è stato immerso in un consensus anti-politico, e quindi alternative da questo punto di vista non ci sono state. Si può discutere se l’elettore sia in grado di cogliere novità che la stessa politica stenta a produrre. Non si può oggettivamente ignorare qualche progresso che la dignità e il primato della politica hanno segnato a proprio favore, dall’antieuropeismo alle corde alla liberazione dalle più sesquipedali idee: come quella che la competenza non serva, se non sia addirittura dannosa.
L’Italia tuttavia resta un cantiere, e la sua una transizione priva di approdo. Basta un nuovo discorso, occorrono nuovi soggetti, o sarebbe sufficiente un passaggio generazionale? Qualche elemento giunge dall’ultimo referendum, dove a sorpresa non solo tra i ceti più informati e attrezzati ma soprattutto tra i giovani ha prevalso, a sorpresa, la posizione di maggiore salvaguardia della dignità delle istituzioni rappresentative contro slogan, figli del trentennio antipolitico, fin troppo facili per resistervi. C’è una nuova domanda di politica che passa attraverso una riabilitazione del rapporto rappresentativo, sia nella sua dimensione societaria che istituzionale. Nessun ritorno alla “prima Repubblica” è auspicabile o comunque possibile. I partiti, e la vita, oggi sono molto diversi da quello che erano negli anni ’80. Ma resta pur sempre un gap tra noi e gli altri paesi occidentali avanzati. Ovunque fa capolino un po’ di populismo, ma siamo gli unici che si permettono il lusso di non esprimere in modo coerente un pensiero alternativo ed è difficile non cogliere una relazione con le peformances del sistema.
Le idee partono sempre da nicchie e avanguardie: e poi, per vasi comunicanti, circolano nel corpo sociale, e a certe condizioni si diffondono fino a diventare senso comune. Trent’anni sono bastati per mettere in moto un movimento dialettico di lungo respiro? E’ una domanda montante, quella di un ritorno alla serietà della politica, o resterà confinata in minoranze riflessive? Ed eventualmente chi saprà raccoglierla? La risposta a queste domande è la risposta non solo alla chiusura della transizione, ma probabilmente anche alla crisi italiana: che si manifesta tra l’altro in un declino di vitalità del sistema e di ristagno delle chances di vita che va avanti ormai da molto tempo.
[1] G. DE ROSA, La transizione infinita. Diario politico 1990-1996, Laterza, 1997.
[2] Come chiudere la transizione, a cura di S. Ceccanti e S. Vassallo, il Mulino, 2004.
[3] M. PLUTINO, Dinamiche di una democrazia parlamentare, Carocci, 2015.
[4] Basti citare E. CHELI, Riflessi della transizione nella forma di governo, in Quaderni costituzionali, 1994.

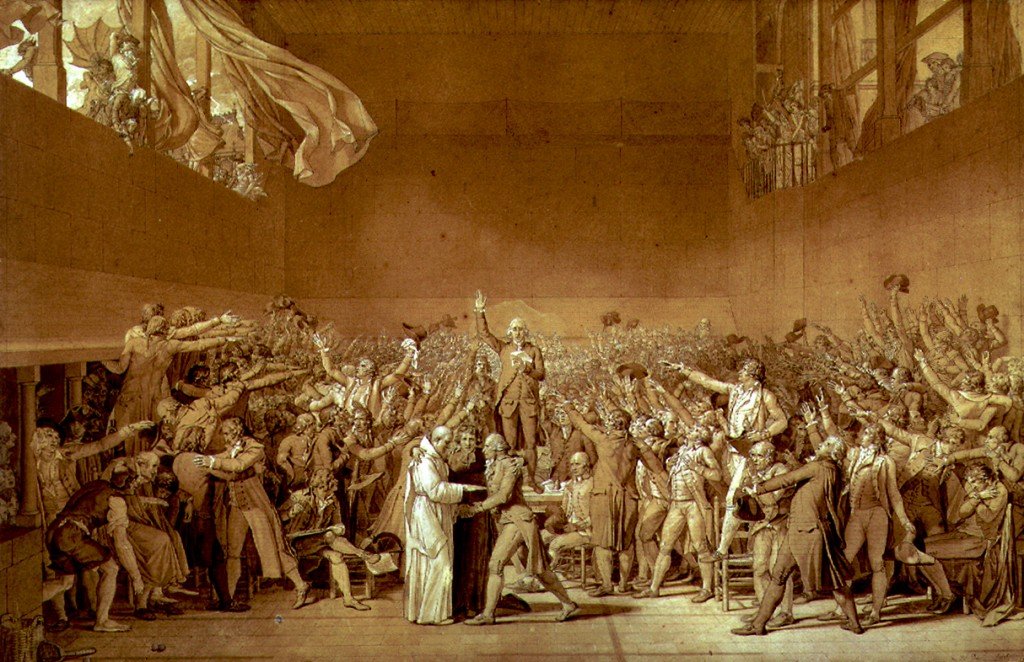



Scrivi un commento