Il 22 gennaio 1944 io c’ero. Avevo poco più di otto anni ma ricordo benissimo quel periodo come ricordo episodi più remoti, che persino mia madre rimaneva meravigliata di questa mia memoria.
Tuttavia sto sempre molto attento a non confondere ricordi e memoria. I ricordi sono fallaci. Dipendono dal tempo passato, dall’età, dalla salute e, soprattutto, dalle circostanze in cui si ricorda.
La memoria costituisce invece l’elaborazione dell’esperienza vissuta. Un’astrazione importante, dipendente dall’impegno e dalla capacità di riflessione.
Il ricordo di quei giorni mi ha impresso nel tempo delle particolari considerazioni che sto qui a raccontarvi.
In quel periodo stavo a Cisterna – un paese a 18 chilometri da Anzio – e impegnavo il mio tempo facendo quello che i ragazzini di paese facevano spesso: giocavamo a sassate. Qualche volta, in momenti abbastanza tesi, mia madre mi faceva portare una frittata a mio padre che stava nascosto in una casa fuori dal paese per evitare i rastrellamenti dei tedeschi. Rastrellamenti é una parola che oggi si usa poco e non con quell’atroce significato.
Proprio in quei giorni tra noi ragazzini correva voce che “venti e ventuno Anzio e Nettuno”, ripetendo forse inconsapevolmente una voce che era stata carpita da Radio Londra. Ci si aspettava, ma con molta indifferenza, qualche bombardamento che non avvenne.
Invece la notte del 22 fu un inferno. Le cannonate assordanti, il panico, gli uomini per le strade di mattina presto incuranti di possibili rastrellamenti tedeschi, i tedeschi invece in fuga su camion e motociclette. Le cannonate non smettevano e già correvano voci di distruzioni di case di campagna e in periferia sulla strada per Anzio e Nettuno.
I maschi – così erano chiamati gli adulti, mariti, padri, zii e fratelli maggiori – furono inviati a cercare un rifugio sicuro, e mio padre, che allora aveva 36 anni e tre figli, trovò con altri amici una grotta tra le tante di quella zona, a 18 metri sottoterra, umida, fredda e bagnata dove ci riparammo con alcune altre famiglie e ci rimanemmo fino all’11 febbraio quando, di notte, dopo 22 giorni, ci portarono a Roma, con i torpedoni, gli avanguardisti: un viaggio rocambolesco di sette/otto ore per percorrere circa 50 chilometri tra strade dissestate e paesi distrutti come Velletri, Genzano, Ariccia e Albano.
La vita in grotta fu difficile. In quel periodo c’erano circa 20 incursioni aeree al giorno. Per garantirci una via di fuga i maschi ruppero una parete che ci univa ai sotterranei di Palazzo Caetani. Un palazzo oggi da visitare. Molto bello.
Alla rottura di quel diaframma una ventata puzzolente invase la nostra grotta e quando con mio padre andai a visitare quei sotterranei alla ricerca di conoscenti, tra circa 2.000 rifugiati, vidi una miseria che appunto ancora mi ricordo e che mi dette il senso della guerra.
Una guerra dove si soffriva la fame. La fame non è l’appetito, quando si ha la certezza che prima o poi si mangia. La fame è sapere che non c’è quasi speranza.
L’altra dimensione esistenziale era la paura che si vedeva nei visi e nei pianti delle donne più anziane. Una paura indescrivibile che forse oggi definirei fatale.
E poi c’erano i morti. Ho riflettuto spesso su quei morti che io bambino vedevo con l’indifferenza dei bambini. Come espressioni della natura. Ma il significato di quei morti lo vedevo nel dolore di mia madre che piangeva un fratello morto sotto le bombe. Nella disperazione delle madri, delle figlie e delle mogli per i loro cari morti così tragicamente.
E questi ricordi mi affiorarono in seguito. Più maturi. Quando al Liceo mi fecero ammirare i versi di Orazio per cui “è dolce e bello morire per la patria” mi chiesi perché morire. Io che non ero uno studente provetto, anche se leggevo fuori della scuola Fenoglio e Fitzgerald, mi ricordai che, nell’Odissea, Achille rispondeva a Ulisse dicendo che lui avrebbe preferito essere vivo anziché defunto nell’Ade. Ero tifoso di Ettore, ma quest’umanità di Achille mi fece riflettere e detti un senso a quei ricordi e questa inutilità della morte mi ha segnato per tutti gli atti che ho compiuto e che compio e che si traduce nel rispetto per gli altri, nel rispetto per la vita.




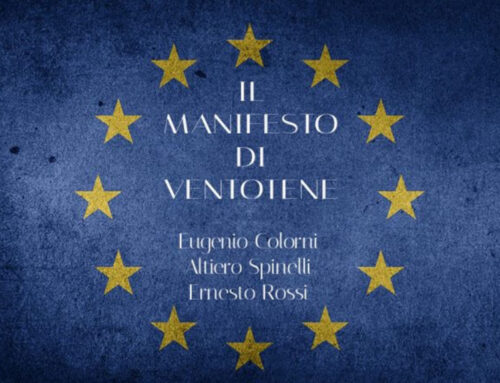
Scrivi un commento